Ultima puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Tutto il quadro che abbiamo sin qui ricostruito ci dice molto anche di una predisposizione di pensiero secondo la quale ciò che la tecnologia permette, va sempre bene.
È la conferma di un processo culturale che abbiamo ormai imparato a conoscere. Come acutamente ha osservato il sociologo Mauro Magatti nel suo “Libertà immaginarie”, il capitalismo contemporaneo ha definitivamente consegnato alla tecnica (dunque anche alle tecniche organizzative) il problema della definizione dei significati. Ne discende che, se qualcosa è permesso dalla tecnica, allora si può (se non addirittura si deve) fare. Senza la necessità di porsi soverchi problemi aggiuntivi.
Più in particolare, secondo Magatti, il “capitalismo tecno-nichilista” da un lato consegna alla tecnica il problema di decidere ciò che si può o non si può fare e dall’altro apre la strada a una nuova “grande trasformazione” sociale ed economica nella quale la logica della frammentazione (delle identità, dei luoghi, delle carriere, dei legami) impone un “immaginario della libertà” che è, però, anche una “libertà immaginaria”.
Dalla posizione che guarda alla tecnologia con la fideistica speranza di ogni bene futuro, espressa anche dagli apologeti dello SW “senza se e senza ma”, hanno preso le distanze alcuni tra i commentatori più attenti, opportunamente distinguendo tra un fenomeno di prevenzione epidemiologica e l’avverarsi di una strutturale, generalizzata ed epocale svolta nell’organizzazione delle imprese e del lavoro. Nel frattempo, però, in mezzo a questo dibattito stanno i milioni di lavoratori e di lavoratrici che hanno sperimentato (e ancora sperimentano) questa modalità di lavoro per i più del tutto eccezionale, certamente non voluta (non almeno nell’attuale misura e nelle attuali modalità) e spesso mai sperimentata prima della pandemia.
Soprattutto per le donne – specialmente per quelle che sono anche mogli, mamme e caregiver informali di qualche familiare non autosufficiente – questo periodo ha coinciso (ed ancora coincide) con una somma di fatiche associate all’insorgere di fonti, anche inedite, di problemi psico-fisici e di stress (da condividere, poi, con i familiari a loro volta in casa e da lì al lavoro o impegnati nello studio e tutti ristretti in spazi fisici generalmente non sempre adeguati). Un piccolo “inferno domestico” che durante il lockdown della “Fase 1” era (e parzialmente durante la “Fase 2” è ancora) fatto anche di scuole e di strutture di sollievo chiuse o a rischio di chiusura, come anche di assistenza socio-sanitaria spesso interrotta o grandemente ridotta.
Quanto poi agli altri problemi che il “confinamento” lavorativo può provocare una sintesi è stata rilanciata dal World Economic Forum. In particolare sono cinque gli specifici rischi dello “staying at home” che nel loro insieme costituiscono i tratti negativi di un “Demon” (un demone, ma anche una sigla che sta per: “D-device addiction; E-eye strain; M-Mental health problems; O-obesity; N-neck and back pain”).
Chi confonde il “lavoro da remoto forzato” con l’avvento di un generalizzato successo dello SW dovrebbe comprendere che attualmente c’è ben poco della grande ed epica promessa di uno stabile e finalmente raggiunto work-life balance, ma semmai c’è tanto e più complicato impegno per tenere in vita il lavoro, le aziende, i servizi erogati e le relazioni: insomma, tutto l’armamentario old style, analogico ed offline che è mancato e ancora manca alla stragrande maggioranza delle persone.
Ottimismi e meccanicismi
Prima di avviarci alle conclusioni occorre dire che il “lavoro agile” – correttamente inquadrato nella sua prospettiva organizzativa – non è (in sé) né una misura di conciliazione vita-lavoro, né uno strumento che ha l’innato potere di aumentare, da solo, la competitività delle imprese e la produttività del lavoro le quali non crescono unicamente (e soprattutto automaticamente) grazie al miglioramento del “clima” interno e per la sussistenza di buone relazioni con il personale, ma semmai grazie alle innovazioni organizzative frutto di investimenti aziendali associati all’adozione di nuove tecnologie ed alla crescita delle competenze in un quadro di più diffusa partecipazione diretta dei lavoratori e di una loro corresponsabilizzazione rispetto agli obiettivi di business.
La Legge 81/2017 (art. 18, c. 1), invece, identifica proprio in questi due àmbiti (conciliazione e competitività) le finalità essenziali dello SW, ma ciò la norma ha previsto perché il Legislatore si è affidato ad una visione decisamente ottimistica, ossia quella, come rileva Michele Tiraboschi, “di un intervento win-win per lavoratori e imprese capace di ingenerare, di per sé, al pari delle iniziative di welfare aziendale, un incremento della produttività del lavoro e una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro” (così in “Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro”, CSDLE, 335, 2017). Analogamente, Maurizio Del Conte – uno dei “padri” della L. 81/2017 – nella prospettiva di una diffusione dello SW che nel post-pandemia caratterizzerà il lavoro di un numero crescente di aziende e lavoratori, ci avverte che “non è realistico credere che la sua progressione geometrica produca in maniera automatica risultati positivi e che questi risultati positivi riguardino tutti i lavori e tutte le imprese” (così in “Le prospettive del lavoro agile oltre l’emergenza”, in Michel Martone, “Il Lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza”).
La Legge 81/2017 ha sostanzialmente mancato l’appuntamento con un obiettivo che poteva e doveva essere più ampio e strategico: quello di coordinare lo SW con il quadro complessivo delle trasformazioni che il lavoro e i contesti produttivi stanno vivendo; invece si è affidata, in via solo presuntiva, ad un nesso causale meccanicistico tra “lavoro agile” ed incremento delle performance.
È, del resto, ben difficile immaginare che le innovazioni possano prodursi per legge: le norme intervengono, semmai, per sostenerle, per indirizzarle o per disciplinare ex post prassi nel frattempo già invalse (e ciò senz’altro vale anche nel caso della Legge 81/2017, atteso che dello SW, a quella data, esistevano già alcuni esempi da tempo messi in pratica in aziende di grandi dimensioni). Meglio, allora, sarebbe stato se il Legislatore avesse osato di più, puntando lo sguardo sul futuro del lavoro, considerandone la già avviata trasformazione ed offrendo alle imprese una cornice entro la quale sviluppare – ciascuna secondo le proprie strategie e la propria visione – un nuovo modo di intendere e di vivere l’organizzazione del lavoro e il suo rapporto con le nuove modalità produttive che avanzano (la legge, ad esempio, poteva porsi in maggiore sinergia con il “Piano Nazionale Industria 4.0”).
La competitività di un’azienda è il risultato di un mix di fattori sul quale lo SW (come anche il Welfare Aziendale e più in generale le policy di benessere organizzativo), può incidere solo in minima parte. Diversamente accade, invece, per KPI intangibili come il clima, l’employer branding, l’engagement: elementi certo essenziali anche per rendere più competitive le imprese, ma che tuttavia, senza investimenti in tecnologia, in infrastrutture e su altri KPI tangibili, risulterebbero incapaci di sostenere, da sé, la complessiva performance di una qualsivoglia azienda.
Se lo SW, poi, fosse solo conciliazione vita-lavoro (o anche più genericamente uno strumento di work-life balance) non saremmo in presenza di alcuna innovazione di rilievo, ma al più di una modalità aggiuntiva – neppure, poi, così originale – che andrebbe ad affiancarsi ad un corpus normativo dedicato a questo tema già ampiamente presente nel diritto del lavoro (fatto di permessi, banche delle ore, orari “a menu”, sostegni alla genitorialità, discipline speciali per i carichi di cura relativi ad anziani e disabili, ecc.).
Oltre il work-life balance
Più in generale, poi, resta da verificare se lo SW non sia un superamento dello stesso concetto di conciliazione vita-lavoro (ché se così fosse si sarebbe anche in tal modo dimostrata l’impropria indicazione finalistica della Legge 81/2017).
È evidente, infatti, che il concetto stesso di “conciliazione” intende mettere in equilibrio una condizione intorno alla quale aleggia un giudizio negativo (il rapporto conflittuale tra vita privata e lavoro). La stessa ridefinizione della relazione tra tempo e luogo di lavoro, insita nello schema dello SW (e più in generale nell’organizzazione del lavoro “4.0”), evidenzia la contraddizione del concetto di “conciliazione”.
All’aumentare della flessibilità della produzione (e della sua organizzazione), quale portato caratteristico della “Quarta Rivoluzione” industriale, spazio e tempo non sono più concetti interpretabili sulla base delle precedenti impostazioni. Se “lavorare da casa” (o da un altro luogo) diventerà usuale, l’esigenza di bilanciare vita e lavoro cambierà radicalmente e ciò in quanto i due momenti saranno sempre più tra loro (con)fusi: il lavoro dello smart worker, infatti, non è più – e sempre meno sarà – facilmente separabile dal suo spazio privato con una sequenza oraria standard del tipo “8-8-8” (lavoro-vita privata-riposo).
Delle due l’una: o lo SW è una manifestazione del lavoro trasformato in profondità dalle tecnologie informazionali che presuppone la crescente impossibilità (e forse anche la non necessità) di tenere separati i momenti produttivi da quelli “disconnessi” dalla produzione, o non lo è ed allora retrocede ad una modalità di contenimento di un perdurante culturale contrasto tra lavoro e spazi di vita privata e si qualifica come strumento per un migliore work-life balance nel quadro di una concezione del lavoro sostanzialmente non troppo diversa da quella novecentesca che intenderebbe invece superare. Con buona pace dell’avveramento di quell’innovazione e di quel cambiamento che, proprio con la diffusione dello SW, si vorrebbero dimostrare come ormai alla portata, se non già avvenuti, grazie anche all’accelerazione disruptive resa possibile dalla pandemia.
Concludendo: una speranza
Per evitare tutte le distorsioni che abbiamo descritto in queste otto “puntate” – tutte dedicate a comprendere come non confondere lo SW con le sue brutte copie diffusesi con l’emergenza pandemica – sarebbe sufficiente distinguere il grano dal loglio: dire apertamente che quello che si è fatto nella “Fase1” e in questa lunga e complicata “Fase2” non dovrà essere quello che si potrà fare nella “Fase3”, a pandemia terminata o almeno posta realmente sotto controllo.
Ciò anche per ribadire la capacità che le prassi di reale SW possono esprimere nel sostenere l’innovazione di quelle modalità organizzative che presuppongono robusti impegni in termini di change management: dal controllo “qui e ora” alla crescente discrezionalità e responsabilizzazione dei lavoratori rispetto ai risultati del loro operato e secondo logiche partecipative. Proprio queste ultime, nella forma della partecipazione organizzativa (o diretta) sono, a torto, le grandi assenti del dibattito sullo SW, mentre hanno invece molto a che fare con l’organizzazione aziendale “agile”.
Sono questi, insieme alla riprogettazione organizzativa ed alla valutazione degli impatti generali delle nuove modalità di lavoro anche sul piano della stessa vita, alcuni dei temi da decifrare e sui quali concentrare l’attenzione, sapendo che, per ora, le premesse più solide per il compimento della “rivoluzione” (ossia per una reale e diffusa “grande trasformazione” del lavoro e della società) mancano tanto nella maggior parte delle aziende (per evidenti gap culturali e tecnologici ancora tutti da colmare) quanto, soprattutto, nella visione dei policy maker che rispetto alle novità delle trasformazioni digitali (ma la sostanza non cambia, aggiungiamo noi, se le si amplia a quelle organizzative), come aveva a suo tempo rilevato il filosofo Luciano Floridi, compiono due errori: o le trascurano, o le travisano (“La politica non capisce il digitale ed è un grave problema: ecco perché”, agendadigitale.eu, 19.2.2018).
Ne consegue che, anche post-pandemia, lo SW correrà il rischio di essere, nella maggior parte dei casi, solo una diversa modalità di esecuzione di un lavoro subordinato comunque basato su dinamiche tradizionali, ossia fondato su procedure ed esecuzioni sottoposte al controllo gerarchico senza alcuna innovazione sul piano professionale, relazionale ed in particolare fiduciario.
Si rischia una traslazione delle usuali logiche organizzative che, come con un “copia/incolla”, dall’ufficio saranno riportate tel quel nella propria abitazione, passando dagli open-space molto glamour della sede aziendale ad un restricted-space casalingo trasformato in succursale dell’ufficio al quale si è addetti e per di più sempre più confuso con la propria sfera privata, in una perdurante dinamica di contrapposizione e non già di realizzata armonizzazione.
Coloro cui è sin qui andato il merito di aver studiato, promosso e diffuso lo SW avrebbero dovuto ergersi a strenui difensori della sua “purezza” evitando che lo si confondesse con una condizione drammatica ed eccezionale che, per milioni di lavoratori e di lavoratrici, ha prodotto l’esperienza tutt’altro che piacevole ed evoluta del “lavoro da remoto forzato”. Così come avrebbe dovuto spingere i più ad assumere un approccio realista, positivo e responsabile, assumendosi la capacità di una rilettura sistemica capace di cogliere le inevitabili esternalità negative di un repentino processo di remotizzazione di massa delle persone e del lavoro.
Il momento attuale, poi, pur con le sue indubbie criticità, è forse un’occasione imperdibile proprio per fare ricerca anche al fine di poter raccogliere con le “armi” più idonee la reale sfida dell’oggi (e soprattutto di domani) che non è quella di diffondere la “remotizzazione” del lavoro in quanto tale – sbandierando numeri che non possono provare l’adozione effettiva di una diversa prospettiva dalla quale guardare al (e vivere pienamente il) lavoro – ma semmai quella di progettare il nuovo lavoro e definire il percorso più opportuno che dovrà essere seguito in vista di questa nuova stagione dell’organizzazione dell’impresa.
Non c’è molto di bello da portare con noi dal tunnel buio del lockdown e della “Fase 2” nel quale la socialità (inclusa quella del lavoro) è implosa negli schermi dei nostri pc, mentre c’è tanto di luminoso da vivere tornando a stare insieme “nel” lavoro e quindi – anche fisicamente – “con” le persone che hanno sin qui condiviso le nostre esperienze professionali.
Il che non toglie che si possa essere ancor più soddisfatti se, nel giusto mix di “presenza” e “remoto” che ogni organizzazione saprà determinare, si potrà liberamente – e soprattutto volontariamente – fruire di una modalità diversa con la quale lavorare, secondo regole, modalità e tempi ridefiniti nell’ambito di un rapporto fiduciario figlio di relazioni umane e di rinnovati rapporti professionali più ricchi e motivanti. Ciò, va sùbito ribadito, non come concessione di un benefit e come plus organizzativo a rinforzo dello status di un’élite, ma come risultato trasformativo e generativo di un potente e stimolante cambio di paradigma nel fare impresa che, come si comprende, non può costruirsi per legge o per contratto o grazie ad un supposto potere “taumaturgico” che la tecnologia in sé non ha (né, men che meno, può avere una pandemia), ma che può discendere solo da una profonda evoluzione culturale.
Non c’è alcun dubbio che, una volta vinta la battaglia contro il coronavirus, la “Fase 3” schiuderà le porte ad una diversa concezione del lavoro – come anche di molto altro – e che non si potrà non tenere conto delle “scoperte” che avremo fatto sino ad allora.
Prepariamoci, dunque, ad intraprendere percorsi inediti, ma per poter sostenere seriamente che da domani “nulla sarà più come prima” è necessario non farsi trasportare da effimere fantasie ed è, invece, necessario dare spazio ad un soprassalto di pensiero, di visione e di profonda analisi anzitutto uscendo, come ricorda Francesco Seghezzi, da quella serpeggiante “convinzione deterministica che la crisi in corso per forza di cose cambierà, e in meglio, l’organizzazione del lavoro. Si tratta di un pensiero ingannevole e che scarica le responsabilità dell’oggi, in primis quella di pensare a nuovi paradigmi approfittando di ciò che sta accadendo, su una mano invisibile che si rivela sempre essere una grande illusione” (in “Lavoro agile, cosa resta dopo il lockdown”, Bollettino ADAPT, 20.7.2020, n. 29).
Dobbiamo evitare di consegnare (unicamente) alla tecnologia e alle tecniche la dotazione di senso e di significato da attribuire alle trasformazioni destinate a modificare profondamente non soltanto la geografia economica ed imprenditoriale, ma anche gli stessi modelli antropologici del lavoro (compresi quelli della scuola e dell’università), i paradigmi culturali, le idee di città, di socialità, di esperienza vitale.
Allargando lo sguardo si potranno superare i limiti del dibattito attuale che mostra tutti i suoi “limiti di comprensione delle sfide più radicali e profonde che lo smart working pone al nostro modo di concepire il lavoro e l’organizzazione dell’intera società” perché “ad essere messe in discussione sono categorie concettuali (il posto di lavoro) ed aggregazioni sociali (non solo le aziende), ma anche le aree urbane”. È quindi in gioco, complessivamente, “il progetto politico di società entro cui collocare i processi economici e le relative scelte organizzative e manageriali” (Michele Tiraboschi, “Smart working: la prospettiva giuridica non basta”, in Bollettino ADAPT, n. 34, 21.9.2020.
La sfida, come si comprende, è epocale e proprio per questo occorre mettere in cortocircuito la lettura sbagliata che s’è data del fenomeno e ridisegnare, con obiettività, la sua corretta dimensione e soprattutto sostenerne lo sviluppo futuro che è certamente auspicabile, ma solo nella misura in cui sia anche umanisticamente sostenibile.
Umanamente lo è senz’altro, come abbiamo saputo dimostrare a noi stessi, anche drammaticamente, in questi lunghi mesi che, purtroppo, non dimenticheremo mai.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



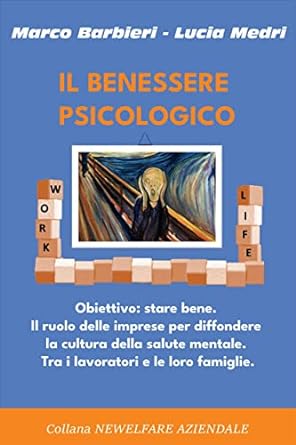













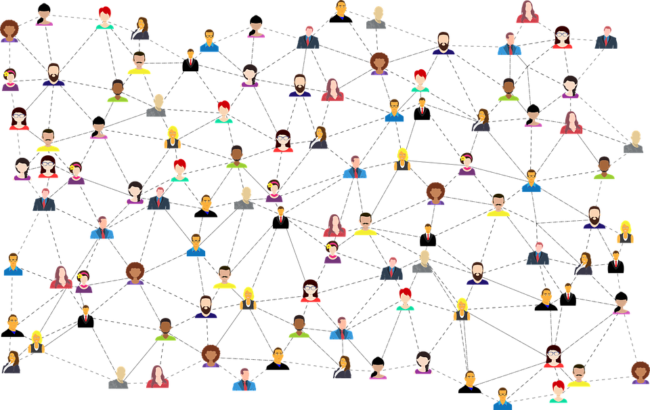


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025