Quarta puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Se, come abbiamo visto, non c’è condivisione circa la necessità di una nuova legge sullo SW (o di una riforma di quella già in esistente), a ben diverse conclusioni, invece, occorre pervenire affrontando la rivendicazione avanzata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori: quella del riconoscimento della centralità della contrattazione collettiva (il cui ruolo ed apporto non è stato previsto – né peraltro impedito – dalla L. 81/2017).
Nelle aziende nelle quali sono attive policy di SW spesso (ed anche ben prima della pubblicazione della legge citata) esse sono state definite attraverso la stipula di appositi contratti sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Proprio la contrattazione, soprattutto aziendale, ha quindi sin dall’inizio rappresentato la principale fonte di regolazione del “lavoro agile” in Italia.
Se lo SW si affermerà (nei numeri e per i benefici che può generare), tale successo sarà testimoniato dall’estensione della platea dei lavoratori coinvolti: da fenomeno sperimentale e caratteristico di un’élite di prescelti (erano solo 570 mila prima della pandemia) diventerà, allora, una prassi collettiva e se così sarà non si vede davvero come possa ancora perdurare l’utopia del “lavoro agile” senza intermediazione sindacale.
Anche qui, però, il rischio di quella “giuridificazione” di cui abbiamo parlato nella precedente “puntata”, è dietro l’angolo: la questione, infatti, è quale livello di contrattazione debba occuparsene, se quello nazionale di categoria o quello di secondo livello e con quale grado d’intensità.
Quale contrattazione
La contrattazione nazionale – come è stato anche per la stessa L. 81/2017 – dovrebbe fornire una cornice soft che possa svolgere una funzione di nudging del “lavoro agile” assumendosi il compito di precisare che la finalità dello SW – in un più ampio quadro di investimenti e di adeguamenti organizzativi – è quella di favorire incrementi della produttività (in tal modo strettamente collegandosi ai meccanismi di gain sharing e di partecipazione diretta dei lavoratori: un tema, quest’ultimo, sostanzialmente – ma a torto – assente dal dibattito sul “lavoro agile”).
Un altro ambito riservabile alla contrattazione nazionale potrà essere quello utile ad indirizzare l’autonomia delle parti su temi generali, ma assai delicati come, ad esempio, quelli afferenti all’esercizio dei poteri di controllo del datore di lavoro rispetto alle esigenze di privacy dei lavoratori (al lavoro smart, inutile nasconderlo, possono corrispondere controlli non meno “intelligenti”, ma anche invasivi).
Alla contrattazione aziendale (e a quella territoriale) andrebbe, invece, il compito di definire il quadro che meglio si attagli alle singole imprese fornendo, così, la cornice di riferimento per i successivi accordi individuali (inclusivi di obiettivi e modalità di misurazione dei risultati) la cui centralità non può essere dimenticata, trattandosi di definire le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del singolo dipendente che, una volta “remotizzato” per una parte del suo tempo, dovrà poter contare su una disciplina che tenga conto di specificità che solo singolarmente possono essere apprezzate e tradotte, appunto, in uno specifico accordo individuale.
È quest’ultima la sede per disciplinare aspetti come, tra gli altri, quelli attinenti all’esercizio del “diritto alla disconnessione” (evocato, ma in dettaglio non disciplinato dall’attuale normativa). Questa materia è proprio negli accordi aziendali ed individuali che ha trovato, sin qui, le sue traduzioni pratiche e gli adattamenti del caso (per quanto di rado realmente “agili”).
Sullo sfondo stanno poi le indicazioni di fonte sovranazionale che gli attori delle relazioni industriali attendono: il tema della “disconnessione” è, infatti, allo studio dell’Europarlamento che intende fissare degli standard comuni che dovrebbero confluire in un’apposita Direttiva la cui pubblicazione è prevista per quest’anno.
“…E io pago!”
Quella dell’accordo aziendale sarà verosimilmente anche la sede nella quale troverà composizione un’altra questione che sta montando in questi mesi di “remotizzazione forzata”: quella dei costi del “lavoro agile” sostenuti dai lavoratori (ad esempio quelli della connessione internet e quelli delle utenze casalinghe o la sempre viva questione della corresponsione dei buoni pasto).
Contro il riconoscimento di questi costi – si fa notare da parte datoriale – militerebbe la sussistenza degl’innegabili risparmi che derivano allo smart worker proprio per il fatto di non doversi recare in azienda con la precedente frequenza (si tratta degli effetti che riguardano la riduzione dei costi, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, del cd. commuting). Ne consegue – si fa notare – che la busta-paga dello smart worker indirettamente migliora.
Da parte sindacale si è eccepito che le aziende di saving ne fanno anche di più: basti pensare alla riduzione degli spazi e delle conseguenti spese generali o alle disdette di molte locazioni di sedi diventate adesso troppo grandi rispetto all’occupazione media degli uffici che s’ipotizza di registrare per il futuro. Su questo sono state fatte delle simulazioni circa il quantum ascrivibile alla riduzione di tali costi e quindi delle spese generali per ogni postazione fisica trasformata in lavoro smart: si va da chi ha sostenuto che l’azienda possa risparmiare fino a 10 mila euro per ogni posizione “smartata”, fino a quella sostenuta dai manager intervistati dall’harvardiano Prof. Prithwiraj Choudhury che nell’articolo “Our work-from-anywhere future” (Harvard Business Review, novembre-dicembre, 2020) rileva come “The net benefit (…) including the productivity increases and property cost savings (…) equals $ 18.000 a year for each worker”. In una posizione mediana, invece, si collocano le stime elaborate da OECD-LEED secondo cui “a typical employer can save approximately USD 11.000 per year for every person who works remotely half of the time”.
La questione dei costi e dei risparmi derivanti dallo SW può sembrare una battaglia di retrovia, ma almeno con riferimento al personale civile delle PA occorre segnalare che la L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), all’art.1, comma 870, prende in considerazione proprio alcuni saving datoriali derivanti dalla remotizzazione del lavoro per delineare un’interessante nuova fonte (sia pure solo “emergenziale”) di finanziamento del Welfare Aziendale.
La norma prevede, infatti, che “le risorse destinate (…) a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario (…) non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio (…) possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa (…) i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”. Ebbene, una riduzione dei costi per lavoro straordinario è quella che deriva dallo SW che (almeno in ambito pubblico) è anche spesso la ragione del taglio secco dei buoni pasto (due impatti di non poco conto per le buste-paga medie). Con questa norma quello che esce dalla porta (le tasche degli smart worker) potrebbe allora rientrare dalla finestra (sempre le tasche degli smart worker) con tutti i benefici che gli interventi di Welfare Aziendale sono in grado di generare. Questo meccanismo, poi, potrebbe ispirare anche le aziende private che alimentando il welfare con i risparmi “agili” potrebbero trovare la “quadra” su queste rivendicazioni.
Sul tema del “chi paga” una soluzione, sia pure nella diversa logica della compensazione dei costi sopportati dai lavoratori, si stanno muovendo i tedeschi. In Germania ha preso forma una proposta bipartisan contenuta in un accordo tra i partiti CDU e SPD che intende riconoscere ai lavoratori un rimborso à forfait delle spese vive sostenute per la gestione del cd. “Homeoffice” (così, più realisticamente, i tedeschi chiamano l’attuale condizione del lavoro da remoto).
La Germania, peraltro, è anche la patria di un’altra proposta: quella della Smart Working Tax avanzata proprio considerando i risparmi che gli smart worker riescono a conseguire non sostenendo più alcuni costi e che si trasformano, da un lato, in un minor giro d’affari per una parte dell’economia (trasporti, combustibili, ristorazione) e dall’altra, appunto, in un miglioramento della loro condizione economica che andrebbe, ad avviso dei proponenti, ripartita con le “vittime economiche” della pandemia. Si tratta della proposta, avanzata nel mese di novembre 2020, da Deutsche Bank contenuta nello studio “What we must do to rebuild”.
La Smart Working Tax si sostanzierebbe nell’applicazione di una tassa del 5% a carico di tutti i lavoratori che continuano a lavorare da remoto, destinando il gettito così ottenuto a favore di chi ha perso o sospeso la sua attività in conseguenza della pandemia o sia stato costretto, per il tipo di attività svolta, a continuare a lavorare in azienda. Questa tassa, sostiene la banca tedesca, consentirebbe di “raccogliere 49 miliardi di euro all’anno negli USA, 20 miliardi di euro in Germania e 7 miliardi di sterline nel Regno Unito”, che potrebbero “finanziare sussidi per i lavoratori meno pagati che di solito non possono lavorare da casa”. Superfluo aggiungere che l’idea, in Italia, non ha riscosso alcun successo.
Smart Working e free-rider
C’è poi un’altra conseguenza dello SW foriera di saving per le aziende, ma della quale poco si discute. Stavolta è direttamente in gioco il costo del personale e su questo aspetto gli smart worker e i sindacati non si sono ancora ben soffermati. Alludiamo alla capacità del “lavoro agile” di rendere più semplice identificare sacche di inattività (anche preesistenti) e di “scovare” i lavoratori meno performanti (i free-rider, quelli che “in presenza” – magari nei grandi open-space – sono capaci di “mimetizzarsi” dietro lo schermo del pc).
È evidente che lavorando in maniera isolata rispetto al reparto o al team cui fisicamente partecipava in azienda, lo smart worker poco collaborativo lo si noti immediatamente o almeno più facilmente, dovendosi misurare il lavoro sui risultati di ciascuno, piuttosto che solo sulla durata del (e sulla presenza al) lavoro.
A parlare apertamente di questo, gliene va dato atto, se n’è fatta carico il Ministro della Funzione Pubblica responsabile del settore più afflitto dalla necessità di migliorare le performance. Secondo il Ministro Fabiana Dadone una delle “funzioni” dello SW (il che spiega il particolare impegno profuso per la sua diffusione nelle PA, pur in quadro irto di non poche difficoltà culturali e strutturali tra le quali proprio la carenza di una cultura della performance) è appunto questa: facilita l’identificazione del lavoratore poco produttivo. Lo SW à la Dadone, infatti, sarebbe un premio per coloro che lo praticano e da qui la rovente polemica con i sindacati nata sulla corrispondente, contraria e paradossale funzione “punitiva” così assegnata al rientro in ufficio da disporsi per i lavoratori non “agili”, ossia quelli con una “resa” inferiore alle attese.
Busta paga smart?
Mentre, ragionando a corto termine, ciascuna delle parti lamenta il suo personale “e io pago!” e si tratteggia il disegno di uno SW visto come benefit, all’orizzonte e sul medio/lungo termine si profila dell’altro. Gli smart worker sono (attualmente) tutelati dalla L. 81/2017 che impone la parità di trattamento retributivo rispetto al personale che lavora in azienda, ma con lo sviluppo – e soprattutto con il corretto radicamento culturale sotteso a questa modalità di lavoro – non può non immaginarsi anche una ridefinizione della stessa struttura della retribuzione che terrà conto della finalità del “lavoro agile” che è quella non già di realizzare un maggior benessere per il lavoratore (ciò sarà al più un outcome della rinnovata organizzazione del lavoro nel quale si inserisce lo SW), ma quella di perseguire incrementi della competitività delle imprese e della produttività del lavoro ottenibili sulla base del raggiungimento di target da conseguire mediante un lavoro sempre più responsabilizzato e fiduciariamente svolto con crescenti dosi di discrezionalità operativa, dove “l’agilità” che conta non è quella (astratta) del lavoro, ma ovviamente quella (concreta) del lavoratore.
Appare evidente che questa impostazione – la sola che, insieme ad altri specifici presupposti, possa far parlare di autentico SW – è destinata a modificare la subordinazione e lo stesso sinallagma contrattuale nel quale la retribuzione non è più unicamente il corrispettivo del tempo necessario ad eseguire la prestazione. Un simile passaggio, dopo aver risolto quello dell’esatta portata delle trasformazioni organizzative sottostanti, sarà il vero tema centrale del dibattito sul “lavoro agile” (un tema del quale – ad eccezione dei giuslavoristi – non sembrano molto occuparsi né i guru dello SW, né le parti sociali né, tantomeno, gli stessi lavoratori).
Non affrontare questo aspetto implica il rischio di confinare lo SW in una riduttiva dimensione (quella delle prassi di conciliazione vita-lavoro) che non consentirà di sfruttare pienamente né le opportunità che il “lavoro agile” può offrire, né di portare a compimento la “grande trasformazione” del lavoro che deve accompagnare quella dei sistemi produttivi per disegnare un quadro coerente e sinergico che metta insieme tecnologia, organizzazione e lavoro in quello scenario “4.0”, anch’esso tanto decantato, ma (come l’autentico SW) sin qui ancora ben poco diffuso e realizzato.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



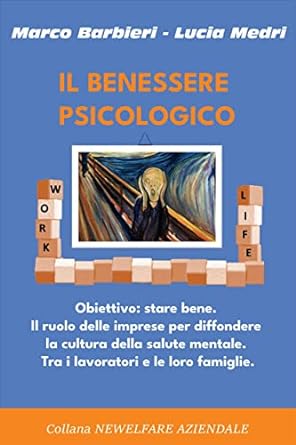
















L’educazione finanziaria potenzia il welfare aziendale
Novembre 18, 2024