Quinta puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
La piccola e breve storia dello smart working (SW) italiano si è immersa – come il raggio di luce che si immerge in un prisma esplodendo in una moltitudine di colori – passando attraverso quello del lockdown durante il quale si stima che otto milioni di lavoratori e lavoratrici siano stati frettolosamente costretti ad “agilizzarsi” all’interno delle loro abitazioni.
Ad eccezione delle aziende già attrezzate per resistere a un simile impatto, questo “biblico” esodo dagli uffici ha fatto perdere allo SW la sua connotazione di strumento coerente con una realizzata (previa e complessa) trasformazione della cultura e dell’impianto organizzativo dell’impresa e gliene ha fatta assumere un’altra (oltre a quella squisitamente prevenzionale) del tutto differente, spesso utopica e pericolosamente irrealistica: quella di rappresentare l’avvento di una nuova “civiltà del lavoro” intesa come la fisica liberazione delle persone “dal” luogo di lavoro e di conseguenza “del” lavoro dai suoi limiti di tempo, di luogo e di relazione imposti dallo sviluppo razionalizzante della modernità e della società industriale.
Immunitas Vs. Communitas
Sostenere – come pure è stato fatto – che la massima aspirazione della contemporaneità sarebbe quella di poter lavorare in SW come regola, ossia potenzialmente anche “sempre” e “per sempre”, rendendo, di fatto, eccezionale o addirittura superflua la presenza delle persone in ufficio, significa accedere ad una pericolosa visione del futuro nella quale si annidano tutte le criticità connesse alla tentazione di spostare anche il lavoro all’interno di una lettura dei fenomeni sociali che si fa obbediente al sistema sperimentale della scienza e della tecnica, senza adeguate premesse di tipo filosofico e sociologico.
Il rischio è quello di cedere sempre più all’individualismo e di perdere il senso della communitas. Questo riguarda molti aspetti della nostra vita e vale anche per le comunità espresse dalle (e nelle) aziende in quanto luoghi di un lavoro che proprio le relazioni umane (prima ancora che quelle tecnologiche) rendono possibile.
Il rischio è quello di accedere ad una cultura dell’immunitas (sulla scia di quella oggi ricercata dalla scienza medica con i vaccini) sostenuta da un distanziamento strutturale e definitivo delle persone (“sociale”, come non per caso è definito, anziché “personale” o “fisico”) che, in precedenza, erano invece (ri)unite “nel” (e “dal”) luogo di lavoro e la cui immunizzazione si realizza ora per il tramite della sua “virtualizzazione”, grazie al suo definitivo trasferimento sul web.
Non più “vado a lavorare” (relazioni umane), ma “mi collego al lavoro” (relazioni informatiche, connessioni). Non più “incontri di lavoro”, ma semplici “visioni” (di colleghi, clienti e fornitori) tramite piattaforme via Internet.
In chi propone che questo debba essere il “new normal” prevalente ed altamente desiderabile, alberga una propensione molto individualistica e forse anche egoistica, quasi un ripiegamento su sé stessi, che consente di immaginare di poter “vivere” fuori dai contesti umani e al limite anche solo dentro “ambienti” unicamente digitali, come se il lavoro di domani possa essere svolto adottando lo stile di vita di una sorta di hikikomori. Aleggia qui anche una certa “claustrofilia”, come direbbe Pier Aldo Rovatti nel suo “In virus veritas”.
Il “modello Twitter”
Questa utopia ha tratto la sua linfa grazie alle affermazioni di alcune delle più note società che gestiscono i social network (Twitter e Facebook, ad esempio) che possono contare, come noto, su miliardi di follower che ne hanno poi rilanciato l’idea.
Queste aziende ci hanno recentemente informato che i propri collaboratori saranno collocati (o comunque potranno lavorare) in SW in modo permanente e ciò anche dopo la scoperta del vaccino che previene il contagio da Covid-19 (come a dire che, per queste aziende, l’immunitas sanitaria non è comunque sufficiente, né il presupposto, per ricreare la communitas).
È pur vero che il “modello Twitter” è già stato respinto da altre imprese hi-tech come, ad esempio, Microsoft che per bocca del CEO Satya Nadella, in un’intervista al “New York Times”, ha sottolineato come una simile prassi potrebbe portare a conseguenze negative, prima fra tutte la perdita dei rapporti umani all’interno dell’azienda.
Il rischio, sostiene Nadella, è che “a un dogma se ne sostituisca un altro” ossia che dall’abitudine di lavorare unicamente in ufficio si passi a quella di lavorare solo da casa, per il che si chiedeva: “Che ne sarebbe della salute mentale?”, “Che ne sarebbe delle connessioni e della costruzione di relazioni di gruppo?”. Il timore è che si stia “bruciando parte del capitale sociale che abbiamo costruito” (corriere.it, 19.5.2020).
Una visione confermata anche da alcune ricerche che hanno evidenziato come la “worker efficiency […] improves with low levels of telework but decreases with excessive telework” (OECD-LEED, paper 2020/10).
A casa “come al lavoro” o al lavoro “come a casa”?
È da imprese come Facebook, Google, Apple ed altre che ci arrivano le immagini di uffici fatti di relax room, aree con i videogame, biliardini e tavoli da ping-pong che tanto ricordano le stanze dei nostri adolescenti.
Dopo aver disegnato luoghi di lavoro idilliaci, nei quali i lavoratori potevano sentirsi “come a casa”, quelle stesse aziende – con un improvviso e totale cambio di orientamento – vogliono ora dirci che sarà invece proprio a casa che ci si potrà sentire “come in ufficio”, con un’evidente inversione dei fattori che – contrariamente all’assunto matematico – modifica eccome il “prodotto” perché qui non parliamo di numeri, ma di persone.
Vale senz’altro la pena ricordare due celebri casi di “indietro tutta” nella scelta della remotizzazione di massa del lavoro che si sono verificati prima della pandemia, ma comunque non molto tempo fa.
Sono casi di cui non si parla più perché sono distonici rispetto al mainstream, ma sono, invece, piuttosto significativi perché riferibili proprio a due ben note hi-tech company: IBM e Yahoo.
Entrambe le società – pioniere alcuni anni or sono del WFH (Working From Home, secondo la terminologia statunitense) – hanno successivamente azzerato l’esperimento del lavoro smart perché questo aveva deluso le aspettative.
Le due imprese, infatti, erano corse a riallestire i propri uffici migliorandone il layout perché, in vista del rientro pressoché integrale dei lavoratori, essi potessero trovarli ancora più confortevoli e cool. Tutto ciò, come poteva leggersi nel comunicato aziendale inviato ai lavoratori di Yahoo, era stato giustificato dal fatto che “to become the absolute best place to work, communication and collaboration will be important, so we need to be working side-by-side” atteso che l’azienda aveva anche appurato che “speed and quality are often sacrificed when we work from home” (forbes.com). Un certo scetticismo sullo SW “sempre” e “per sempre” sembra del resto affacciarsi anche nelle considerazioni aziendali sullo scenario post-pandemico americano: le stesse Apple e Google, così come Amazon, Goldman Sachs ed altre ancora, stanno riconsiderando il valore del lavoro “in presenza” (di ciò ne ha dato conto il numero di ottobre 2020 di “Fortune Italia” nell’articolo “Perdere i contatti”, ma interessante è anche la carrellata di opinioni di manager di grandi corporation americane pubblicata dal “New York Times” in “The long, unhappy history of working from home”, 29.6.2020).
Il lavoratore non è una password
Lo SW opportunamente progettato non può essere “per sempre” perché un suo presupposto è il mantenimento dell’inserimento (anche fisico) del lavoratore nell’organizzazione produttiva (come espressamente prevede, almeno in Italia, la stessa Legge 81/2017: il lavoro smart è prestato in parte in azienda e in parte al suo esterno).
Se così non fosse, la disciplina in sé (teoricamente) per nulla collettiva – perché prevede una regolazione solo individuale dello SW, con un contenuto derogatorio rispetto al lavoro standard – rischierebbe di allontanare i lavoratori dal centro operativo, nevralgico ed umano costituito dall’azienda ed alla lunga li allontanerebbe anche dallo stesso contenuto regolatorio del lavoro.
Ne conseguirebbe una limitazione anche sotto il profilo professionale a causa della maggiore difficoltà nel perseguimento dei propri obiettivi di carriera, messi in crisi proprio da una remotizzazione che, facendo sparire la fisicità e la visibilità della persona e le sue relazioni dirette, ridurrebbe il lavoratore ad un flusso di bit aperto e chiuso dal suo login/logout quotidiano nei sistemi aziendali (come sembra preconizzare Domenico De Masi nel suo ultimo libro sull’argomento, dove si legge che “l’ufficio è un sito web” e “il nome del lavoratore è una password”).
In una simile condizione la prova dell’esistenza in vita del lavoratore sarebbe affidata, solo saltuariamente, alla riproduzione della sua immagine sul display del pc, tramite la webcam.
Sono queste le promesse del “new normal”? E sarebbero aziende fatte così le oasi dorate da prendere come esempi del benessere lavorativo?
Non ne siamo certi considerando che tra i big player globali poc’anzi citati si annidano imprese (la stessa Facebook, ma anche la Apple) che offrono alle donne di fare carriera serenamente non già prevedendo qualche innovativo supporto alla conciliazione vita-lavoro e robuste policy di azzeramento del gender gap, bensì pagando terrificanti servizi di Welfare Aziendale come la crioconservazione degli ovociti (repubblica.it, 15.10.2014).
Se queste sono le premesse c’è da ritenere che anche dietro lo SW “per sempre” propugnato dai big player planetari possano annidarsi tentazioni tutt’altro che in grado di creare ambienti a misura dell’umano.
Work-life imbalance
La temporanea e forzata assenza da uffici, fabbriche, scuole, università, officine, insomma dai luoghi in cui ogni giorno milioni di persone si recano, da sempre, per lavorare ci ha dato un’utile lezione culturale e forse addirittura antropologica.
Abbiamo scoperto che ci mancano i colleghi dell’ufficio, come ai ragazzi e ancora di più ai bambini sono mancati e spesso tuttora mancano i compagni di banco o di corso. Certo, ci sono internet e la tecnologia a darci una mano, ma non è facile stare da soli, per mesi, davanti ad uno schermo (e come ci dicono ormai decine di ricerche) anche per molto più tempo che in ufficio (generando così stress e work-life imbalance).
Non è facile continuare a sentirsi parte di un team come quando le relazioni con gli altri si vivevano offline; come quando, oltre alla connessione c’era anche la relazione, la fisicità dei luoghi, degli sguardi e delle parole dette ed ascoltate, con il loro peso e soprattutto con le loro sfumature che non possono essere trasformate e ridotte in un flusso di bit, né essere pienamente rese negli “incontri” in videoconference che invadono la nostra casa (aveva profeticamente ragione Roland Barthes quando sosteneva che la sfera privata è “quella zona di spazio, di tempo, in cui io non sono un’immagine, un oggetto”).
Che “da remoto”, nello SW emergenziale, si lavori di più (e spesso peggio) lo certifica il National Bureau of Economics Research (NBER) che ha pubblicato i risultati di quella che, verosimilmente, deve ritenersi la survey con il campione più ampio mai sin qui indagato sugli aspetti del lavoro “da remoto” (3.143.270 persone impiegate in 21.478 aziende di 16 grandi aree metropolitane del Nord America, dell’Europa – tra le quali Roma e Milano – e del Middle East).
Tra le evidenze più significative vi è quella concernente il fatto che “the average workday span increased by +48,5 minutes” (“Collaborating during coronavirus. The impact of Covid-19 on the nature of work”, NBER Working Paper Series, n. 27612, luglio 2020).
Anche un social network come LinkedIn si è cimentato in una ricerca su questo tema: è così emerso che il 46% del campione si sente più ansioso e stressato, il 48% ha vissuto il lavoro da remoto forzato con un surplus di attività mensile quantificato in circa 20 ore di lavoro in più (immaginiamo non riconosciute come lavoro straordinario e quindi non retribuite: si tratta di quasi tre giorni in più al mese), il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla sua salute mentale e il 21% si sente stressato dal dover essere always on e preso dall’ansia di dover rispondere subito – cd. “telepressione” – mentre sale al 36% la quota di coloro che, a causa di queste sensazioni, ammette persino di fingere di essere impegnato.
Interessanti anche i dati della ricerca “in continuo” (dura da oltre sette mesi e misura l’impatto della pandemia sulla vita degli italiani) realizzata da Nomisma e CRIF (Osservatorio “The Word After Lockdown”): anche in tal caso una percentuale apprezzabile (il 28% degli intervistati) ha registrato un incremento delle ore lavorate e la difficoltà a tenere separate la sfera lavorativa da quella privata a causa della time porosity (il 21% non riesce a “staccare”) mentre il 22% lamenta “senso di solitudine e isolamento”. Evidenze similari emergono anche dalle survey aziendali delle sedi italiane di Facebook e Microsoft (di quest’ultima ne ha data illustrazione a luglio 2020 la “Harvard Business Review”).
Queste ed altre acquisizioni sugli aspetti critici del lavoro da remoto – esasperatisi durante la pandemia – erano, peraltro, disponibili da tempo: il rapporto congiunto ILO-Eurofound (“Working anytime, anywhere: the effects on the world of work”, 2017) aveva già dimostrato come gli smart worker lavorassero spesso di più rispetto ai lavoratori che svolgono la loro attività esclusivamente in azienda. Altre criticità segnalate erano quelle riconducibili al fenomeno dell’always on con insorgenza di patologie fisiche e mentali derivanti dal cd. techno-stress, dall’iper-connettività e dal burnout.
Nella prossima puntata, ritornando in parte anche su questi temi, ci faremo guidare da un signore che del rapporto tra innovazioni e lavoro (“in presenza”) crediamo se ne intendesse almeno un po’: un certo Steve Jobs.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



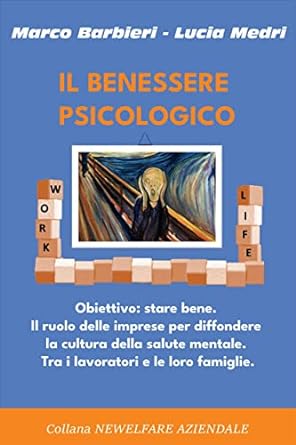
















L’educazione finanziaria potenzia il welfare aziendale
Novembre 18, 2024