Penultima puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Il dibattito sullo SW – sia pure il più delle volte confuso ed inteso in maniera a-tecnica – ha fatto emergere anche talune posizioni che possiamo collocare, a seconda del loro contenuto, tra lo snobistico, il revanscista e il folkloristico.
Pur espresse con proposte tra loro diverse, queste posizioni sono riassumibili nei termini di una vera e propria “Smart Working Euphoria” e si rintracciano facilmente nelle esternazioni a difesa di un lavoro da remoto non solo “per sempre” (il “modello Twitter” di cui abbiamo già detto), ma anche “a tutti i costi” e “costi quel che costi” (ad esempio, all’economia delle grandi città, come dimostra anche un certo anacronistico impulso anti-settentrionale e soprattutto anti-milanese spesso, però, manifestato da chi a Milano o al Nord Italia nemmeno ci vive o ci lavora: sono ben note le polemiche nate dopo alcune affermazioni del Sindaco meneghino Beppe Sala e le successive previsioni sulla fine del “sistema-Milano”).
Nel novero delle posizioni più ardite vi è anche la corrente di pensiero che ritiene sia possibile utilizzare lo SW come idoneo strumento per operazioni da realizzarsi sui più disparati fronti: quello ambientale, quello socio-demografico e financo quello economico e turistico. I teorici di quest’ultimo filone ritengono, ad esempio, che con la massiccia futura diffusione del “lavoro agile” rinasceranno i borghi più ameni e spopolati, risorgeranno le periferie abbandonate e si risolveranno anche i molti ed atavici problemi del Sud Italia.
Ciao Milano! Lavorare da Amalfi…
Quanto ai borghi ameni, ora trasformati in “Smart Village” (banda larga, buona cucina e casette in paese), è ormai celebre il caso del Comune di Santa Fiora sul Monte Amiata (GR) portato ad esempio della possibile sinergia tra SW, rilancio dei territori e del turismo nazionale cui, poi, si sono aggiunte altre località ritenute ideali per poter “lavorare da posti meravigliosi” come sostiene, ad esempio, la homepage di smartway.it promuovendo posti come Fiumefreddo Bruzio (CS), Monte Faito (NA), Monterubaglio (TR), Pergine Valdarno (AR), Montalto Uffugo (CS) e Acquavella (SA). Altre proposte similari sono offerte da thesmace.com e da borgo-office.it (qui, oltre ai borghi, l’offerta è estesa anche alle fattorie, ovviamente anch’esse smart).
Il rilancio del Sud Italia, invece, è al centro di un più vasto progetto portato avanti dall’associazione “South Working – Lavorare dal Sud”. La strategia è semplicissima: lavorare “agile” dalle località del Sud “ripopolando” il Meridione d’Italia con migliaia di smart worker a suo tempo emigrati al Nord (i quali, così, potranno sfruttare il differenziale tra un più basso costo della vita e lo “stipendio di un’azienda di Milano”, oltre a ritornare alla famiglia e ai luoghi di origine.
L’idea, tuttavia, la si deve non già a un gruppo di “rivoluzionari” impiegati stanchi del tran-tran delle metropoli e del “caro-vita” delle città settentrionali (Milano su tutte), ma ad alcuni liberi professionisti (come tali, appunto, liberi di lavorare dove meglio credono). Non si vede, quindi, come questa proposta, come anche quelle degli “Smart Village”, possano allargarsi alla massa dei lavoratori impiegati con un contratto di lavoro subordinato (come pure i loro promotori vorrebbero) e senza la numerosità dei quali gli obiettivi sottesi a questa idea non possono essere raggiunti. Il “South Working”, del resto, è nato dall’idea di Elena Militello, ricercatrice universitaria di origine siciliana e dunque essa stessa, per il lavoro che svolge, non propriamente l’idealtipo del lavoratore italiano medio (come non lo sono gli altri sostenitori del progetto).
Nondimeno l’idea ha avuto una vasta eco sulla stampa nazionale (e non solo) e così, in questi ultimi mesi, si sono versati fiumi d’inchiostro per titolare sulle principali testate nazionali: “Cara Milano lavoro per te da Amalfi. E la sera un bagno a mare”, “Un hub del lavoro agile al Sud per contrastare la fuga dei cervelli”, “Lo Smart Working può diventare il petrolio del Sud” e “Lo Smart Working riporta i giovani al Sud”. Sono solo alcuni esempi: la rassegna stampa su questo argomento è ormai sterminata e la caratteristica è che, salvo rarissime eccezioni, nessun commentatore si è posto qualche domanda in chiave critica, non foss’altro per valutare la reale possibilità della diffusione del fenomeno e la portata pratica del progetto.
A dire il vero un approfondimento c’è stato. È quello realizzato da SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) che, in collaborazione con “South Working-Lavorare dal Sud” ha condotto una specifica ricerca. Questo nuovo fenomeno sociale avrebbe riguardato, stando alle stime, almeno centomila lavoratori meridionali (quindi non molti dei circa due milioni impiegati in aziende del Centro-Nord). Dalla ricerca, presentata nel mese di novembre 2020, è emerso che il 60% degli intervistati (un limitato campione di 803 persone) si trasferirebbe al Sud se fosse loro proposto un progetto di “South Working” che consentisse di mantenere il posto di lavoro nell’azienda del Nord ed ovviamente almeno lo stesso stipendio (come non essere d’accordo?). Tuttavia (il che spiega la quota del 40% non disponibile al “South Working”) vi è una diffusa consapevolezza dei molti svantaggi – evidenziati dagli stessi rispondenti – tra i quali tutti quelli, purtroppo, ben noti: servizi sanitari e di trasporto di minor qualità, poca possibilità di fare carriera, minore offerta di servizi per la famiglia, difficoltà di connessione internet oltre, ovviamente, ai costi del trasferimento.
Fatte salve le eccezioni rappresentate dalle imprese “all remote” del settore ICT (quelle che praticano, oltre al WHF-“Working From Home”, anche il WFA-“Working From Anywhere” e che hanno addetti ubicati in giro per il mondo: in ordine di tempo l’ultima votatasi a questa formula è Spotify), questa narrazione, al pari di altre similari, non ci sembra riesca a vincere l’evidenza data dal fatto che, in generale, nessuna azienda (anche ove si sia compiuto il turnaround culturale ed organizzativo sotteso alla corretta introduzione del “lavoro agile”) potrebbe mai immaginare di avere stabilmente nel suo team lavoratori subordinati che si eclissino per mesi (o per la più parte del tempo) in lontane case “vista mare” o nei più remoti borghi della nostra bella Italia.
È appena il caso di ricordare che all’ubicazione ed alla tipologia del luogo di lavoro dello smart worker il datore di lavoro non potrà mai restare indifferente.
L’idoneità del luogo di lavoro, infatti, ha diretti impatti sul coordinamento con l’attività dell’azienda (non è solo questione di buone connessioni di rete, spesso purtroppo carenti al Sud, ma anche, ad esempio, di necessità di rientro “in presenza” che il lavoro potrebbe imporre anche all’improvviso). Il luogo prescelto per l’esecuzione dell’attività lavorativa rileva anche ai fini della sicurezza del lavoratore stesso e deve soddisfare esigenze di tutela della riservatezza dei dati aziendali trattati, nonché l’agibilità dell’esercizio dei poteri di controllo.
Ma soprattutto, come recita l’art 23 della Legge 81/2017, la scelta del luogo dal quale lavorare “agile” deve essere dettata “da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative” e sempre che, conclude la norma, detta scelta “risponda a criteri di ragionevolezza” da valutarsi, evidentemente, anche sul piano organizzativo e non solo rispetto ai desideri personali.
Infine, è appena il caso di osservare che questi limiti valgono per i reali smart worker che (forse, talvolta, lo si dimentica) sono solo quelli che prestano la propria attività in forza di un contratto di lavoro subordinato: liberi professionisti, free-lance e imprenditori startuppari possono, invece, organizzarsi diversamente prescegliendo la località dalla quale operare senza nessun limite (se non quello imposto dal buon senso).
“Dis-connessi” o “dis-occupati”?
Ma pur quando il lavoro si possa svolgere come vorrebbero i più “radicali” interpreti del “lavoro agile”, allora occorrerà seriamente domandarsi (e se lo devono chiedere anzitutto gli smart worker) perché mai un’azienda dovrebbe avvalersi (senza poterla mai incontrare o incontrandola solo alcune volte all’anno) di una persona che se ne sta a centinaia di chilometri dalla sede dell’impresa o magari anche in un altro Stato. La domanda ha senso perché quella stessa azienda potrebbe disporre delle medesime (o financo delle superiori) competenze di un’analoga figura professionale – anche in tal caso senza incontrarla per mesi (o anche mai) – basata, per esempio, in Cina o in India e magari ridurre ulteriormente il costo delle sue prestazioni acquisendole on demand da piattaforme come UpWork, Amazon Mechanical Turk o Fiverr (alludiamo, ovviamente, a figure che svolgono mansioni più routinarie come, ad esempio, il controllo documentale di note spese, “bolle”, fatture, ecc., ma anche lavori più complessi come taluni task nell’ambito del marketing o nel campo dell’elaborazione e dell’analisi dei dati).
L’attuale esaltazione della “dis-connessione” (fisica) della persona rispetto al luogo tradizionalmente deputato allo svolgimento del lavoro – tanto più, poi, quando si vuole assuma le forme dello SW “per sempre” – rischia, al contempo, di “dis-occupare” il posto (fisico) nel quale si compie l’esecuzione della prestazione: un posto, sin qui, spesso faticosamente conquistato, mantenuto e difeso proprio con il lavoro “in presenza”.
Si apprende, invece, che il nuovo layout che emergerà dalle workplace policy aziendali del cd. “new normal” non solo, da un lato, mirerà a “remotizzare” stabilmente almeno una parte del lavoro (e dei lavoratori), ma che, dall’altro, finirà anche per trasformare il posto fisico – un tempo percepito identitariamente come “proprio” – in una shared-desk, quasi una sorta di ufficio “airbnb” da prenotare tramite apposite App (non a caso già in uso in alcune grandi aziende) e questo non solo per gestire la turnazione imposta dalle attuali necessità del distanziamento anti-contagio, ma perché quella stessa turnazione, in futuro, sarà destinata a restare come nuova prassi di people management.
Quale il rischio potenzialmente insito in questo scenario?
Non è difficile immaginare che esso – ove non sia associato ad una complessiva riprogettazione dell’organizzazione aziendale frutto, a sua volta, di un profondo cambio di paradigma culturale e manageriale – possa condurre, a furia di remotizzazioni per lunghi periodi, anche a “disconnessioni” definitive delle persone dal lavoro che sino a ieri esse svolgevano da quel posto fisico che, nel frattempo (se non lo è già stato) sarà presto soppresso (ossia “dis-occupato”) e trasformato, al più, in una mera “base d’appoggio” sulla quale fare ogni tanto affidamento, come fosse una sorta di pied-à-terre professionale (è il cd. deskless job).
Da qui, poi, potrebbe avviarsi sia un processo di ulteriore concentrazione delle attenzioni dell’organizzazione verso i soli core-worker, sia la sostituzione del lavoratore subordinato per lungo tempo “remotizzato” (e per ciò stesso anche progressivamente a rischio di un crescente disengagement) tramite un più economico outsourcing delle sue mansioni (specie se queste non sono molto complesse) che potrebbero essere svolte, come detto, da altri e ben più “remoti” lavoratori basati in luoghi nei quali il costo del lavoro è nettamente inferiore, ossia prescegliendo ben altri “south worker” in giro per il pianeta.
Tra snobismo, benefit e disuguaglianze
Al progetto del “South Working” (che, va detto, contiene istanze e speranze che hanno certamente un senso sul piano individuale e sociale, ma che per essere soddisfatte necessitano di ben altro) si sono poi aggiunte altre ipotesi, alcune davvero irrealistiche.
Una di esse è il cd. “Holiday Work”: un ossimoro che non merita particolari approfondimenti se non per citare la celebre offerta delle Isole Barbados (12 mesi di “visto”, salutati entusiasticamente sui social da decine di migliaia di smart-dreamer-worker che le spiagge di quelle isole le hanno ancora solo come sfondo dei loro desktop). Un’altra è quella delle crociere per lavoratori “agili” (ad esempio c’è quella della compagnia MSC che ha concepito un’apposita offerta denominata “Smartworking@sea”). Forse mancheremo di fantasia, ma ci risulta difficile immaginare che, regolarmente pagato da un (a dir poco) magnanimo datore di lavoro, un qualunque impiegato – tra una corsetta sul ponte della nave, un drink e una traballante connessione wi-fi tra le onde del mare – possa portare avanti proficuamente il suo lavoro.
Si potrebbe proseguire con il “Birthplace Working” (“lavoro agile” dal borgo natìo), il “Country Working” (quello dalle più belle italiche colline o dalle fattorie) e con altre originalissime “formule”, ma quello che vogliamo qui segnalare è come certe fantasie sottendano, nel loro insieme, un certo disinteresse per le disuguaglianze che esse presuppongono e l’evidente nulla considerazione del serio impegno cui deve far fronte chi lavori alle dipendenze di un’azienda e parallelamente debba magari anche pensare alla sua famiglia (in ciò sta anche lo snobismo insito in queste proposte).
Si ha, così, conferma che da un certo numero dei suoi potenziali beneficiari e da taluni dei suoi propugnatori, lo SW è concepito come un’opportunità elitaria, destinata a lavoratori appartenenti a ben individuate categorie che certo non sono quelle più numerose e comunemente impiegatizie. Ecco allora un’altra evidenza di cosa non sia e non debba mai essere (neppure nella sua percezione soggettiva) il reale SW: un benefit.
Dietro l’angolo, infatti, c’è una possibile (ulteriore) polarizzazione dei cluster aziendali con evidenti possibili nuove fonti di disuguaglianza nel rewarding complessivo (monetario e non monetario) dei dipendenti.
Di questo rischio si è occupata un’analisi messa a punto dall’INAPP (“Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia”, in Policy Brief, n. 20, luglio 2020). Dallo studio emerge che “l’attitudine al lavoro agile favorisce le fasce di reddito più alte, nonché i dipendenti di sesso maschile” e che “l’eventuale diffusione del lavoro agile come modalità di lavoro ordinaria (…) rischia di esacerbare le già esistenti disuguaglianze di reddito in Italia”.
Ecco allora perché, come avverte Francesco Seghezzi di ADAPT, se lo SW oltretutto “fosse concepito come un diritto, cosa che molti sostengono, si delineerebbe una forte disuguaglianza tra chi è in grado di esercitare questo diritto e chi, per condizioni al di fuori della sua volontà, no”.
Un’evidenza ben chiara anche ai ricercatori dello Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ed in particolare al gruppo di ricerca guidato da Nicholas Bloom, docente di Economia alla Stanford’s School of Umanities and Sciences. I loro studi evidenziano come, sul totale delle posizioni lavorative, “only 51 percent of the survey respondents (…) reported being able to work from home at an efficiency rate of 80 percent or more” il che “is generating a time bomb for inequality” perché “more educated, higher-earning employees are far more likely to work from home, so they are continuing to get paid, develop their skills and advance their careers. At the same time, those unable to work from home (…) are being left behind” (“Stanford research provides a snapshot of a new working-from-home economy”, Stanford News, 29.6.2020).
Mors tua, vita mea
La “Smart Working Euphoria” che prescinde dal senso del “collettivo” aziendale e da quello della coesione e della “cittadinanza organizzativa” che il “lavoro agile” – se ben interpretato e realizzato – non distrugge, ma semmai arricchisce di nuove modalità di espressione, ha molto delle logiche individualistiche del nostro tempo che, a loro volta, prescindono dalla tensione verso un’altra non meno essenziale manifestazione di coesione: quella sociale.
Paradossalmente chi esalta l’apparente libertà derivante da un’astratta (ed irrealistica) totale autonomizzazione (facilmente trasformabile in alienante atomizzazione) del lavoro ubiquo non ha còlto uno dei messaggi della pandemia, forse il più evidente: con l’irrompere del coronavirus abbiamo scoperto non già i supposti pregi dell’individualismo e della “grotta” casalinga, ma che siamo tutti strettamente ed umanamente (oltre che tecnologicamente) collegati. Ecco perché anche il disinteresse circa le conseguenze economiche e sociali della sparizione delle persone, ossia del loro essere “in presenza” negli uffici e nei centri cittadini, come nei molti altri luoghi dove la vita è vissuta, è un’altra forma di inaccettabile miopia che non deve poter essere associata ad una modalità di lavoro che, correttamente implementata, può (e deve) invece avere un impatto ben diverso sulle dinamiche e sulle interconnessioni sulle quali sin qui si è basata (e sostanzialmente continuerà a basarsi) la nostra società (trasporti, commercio, servizi, relazioni).
Si prenda, ad esempio, la jacquerie insorta contro i baristi e i commercianti, perché “lavoravamo per consumare buoni pasto e benzina” (così il sociologo Mauro Ferraresi su huffingtonpost.it, 27.6.2020). Sostenere che baristi e ristoratori dovranno cambiare mestiere o più verosimilmente inventarsi un concept di servizio più aggiornato come, ad esempio, trasformarsi in coworking (per il che cominciano ad essere disponibili anche delle app dedicate – come Nibol – che consentono di prenotare postazioni di lavoro nelle caffetterie) ci dice che, se il lavoratore in SW decide di accedere ad un cowo (dunque, in definitiva, si reca in un luogo del tutto assimilabile ad un ufficio) questo conferma “quanto sia importante condividere il proprio spazio di lavoro con altre persone dagli interessi e dagli obiettivi simili” e ciò perché “la socializzazione e gli scambi intellettuali sono aspetti di vitale importanza nella pratica professionale” come ci ricordano Carlo Ratti e Matthew Claudel (“L’evoluzione imprevista dell’ufficio”, IlSole24Ore, 17.4.2016) e come ci aveva ricordato anche Steve Jobs (delle cui opinioni in proposito abbiamo già detto nella precedente puntata).
L’euforia individualistica dello SW è stata poi amplificata (e giustificata) dalle futuribili visioni sulle smart city e le “telepolis” magicamente liberate dal commuting. Niente più traffico, inquinamento e “stress della vita moderna”, come recitava molti anni fa un indimenticato spot pubblicitario. Ma non è che, così facendo, le città risulterebbero liberate anche da migliaia di posti di lavoro nei servizi, come ha segnalato l’ISTAT e come farebbe intuire anche il solo buon senso?
La “Smart Working Euphoria”, proprio perché priva di analisi e non basata su quei corretti approcci muldimensionali e multidisciplinari che sono necessari per irrobustire le pratiche dell’autentico “lavoro agile”, lascerà verosimilmente il tempo che trova, ma non si deve ugualmente correre il rischio che inquini il campo nel quale piantare il seme fecondo delle novità che ci attendono, fra le quali, ovviamente, l’autentico “lavoro agile”.
Queste novità, per poter essere accolte ed indurci a fare concreti passi in avanti, meritano un esame molto rigoroso per la valutazione dei loro impatti complessivi: ne daremo conto nel prossimo articolo, l’ultimo di questa serie di otto interventi.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



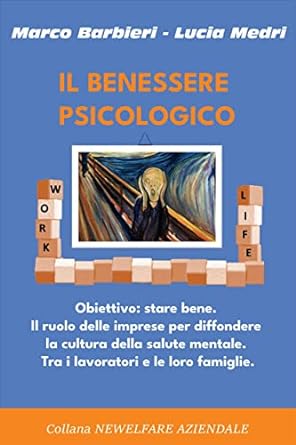













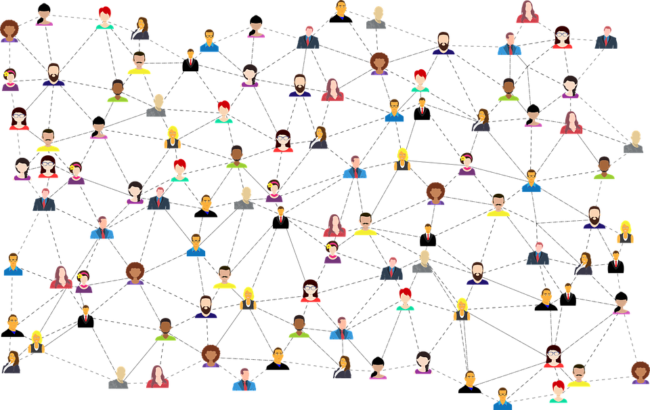


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025