Il primo di una serie di appuntamenti curati da Luca Pesenti e Giovanni Scansani relativi al dibattito sullo smart working. Sarà davvero una rivoluzione “smart”?
“Non l’avrei mai creduto possibile, ma oggi tornando al lavoro mi sono venute le lacrime agli occhi alla vista del parcheggio aziendale pieno zeppo, come prima della pandemia” (da un post su Linkedin pubblicato da un’impiegata il 5 maggio 2020, inizio della “fase2”)
Ben prima dell’inizio del lockdown ci eravamo permessi di rilevare che continuando a sostenere ad ogni piè sospinto che il lavoro svolto ovunque, purché fuori dal tradizionale ufficio, fosse il massimo che l’esperienza lavorativa ci potesse riservare, non si sarebbe reso un buon servizio al “lavoro agile”, ossia a quella specifica modalità di lavoro subordinato che solo in Italia definiamo smart working per quel consueto vezzo anglofilo che in questo caso, peraltro, non ha neppure corrispondenza nella lingua inglese effettivamente parlata.
La politica, ad esempio, nella fase emergenziale, su questo tema è andata “a briglia sciolta”. Contribuendo (certamente in modo inconsapevole, il che è però un’aggravante) a costruire una narrazione che, settimana dopo settimana, si è auto-alimentata grazie al contributo dei media e degli immancabili “competenti” che ne costruivano la trama.
Il problema è che tutti coloro i quali hanno utilizzato (in modo più o meno consapevole) il termine smart working (o anche il meno opportunistico “lavoro agile) dall’inizio di marzo in poi, lo hanno fatto potendo certamente immaginare che quello che stava in realtà andando in scena in buona parte delle case dei 19 milioni di lavoratori dipendenti (così come in quelle dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti) non era il trionfo di una nuova modalità di lavorare a distanza, bensì un’esperienza che per le sue caratteristiche mal si prestava ad essere descritta sia come smart, sia (e, tantomeno) come agile. Quella che durante il lockdown (ed ancora oggi) si è materializzata nelle case della maggior parte dei lavoratori è invece meglio definibile come “misura obbligatoria di distanziamento lavorativo”, il cui obiettivo non era né l’aumento del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, né l’aumento della loro produttività. L’obiettivo esplicito era invece un altro, ed è bene tenerlo sempre a mente: quello di evitare la diffusione del contagio da Covid-19, permettendo al contempo il proseguimento da remoto (ma anche “purchessia”) di tutte le attività di lavoro possibili.
Il richiamo alla memoria di questo obiettivo primario, che ci pare indispensabile ricordare in premessa ad ogni ragionamento su questo tema, avrebbe immediatamente dovuto consentire (ma spesso, e purtroppo, così non è stato) di fare degli utili distinguo, indispensabili per riprendere il cammino cercando di imparare comunque qualcosa dall’esperienza che abbiamo tutti, obtorto collo, dovuto affrontare. Solo attraverso questa strada, più meditata e prudente, riteniamo che possa essere possibile evitare di buttar via il bambino (ovvero il “lavoro agile” nella sua reale essenza) insieme all’acqua sporca (ovvero la retorica dello smart working che quotidianamente si sta sviluppando sui media e attraverso i social).
Veniamo allora al punto che intendiamo invece verificare con questa nostra serie di articoli (saranno almeno tre a partire da questo), ideale continuazione (e necessario approfondimento) di quanto già abbiamo avuto modo di segnalare nelle nostre riflessioni “a caldo” contenute nel primo capitolo dell’e-book Welfare aziendale: e adesso?(disponibile gratuitamente sul sito). La lettura del dibattito che si sta sviluppando in queste ultime settimane ci sembra che stia producendo un processo contrario rispetto a quanto invece auspicabile. Si sta, infatti, salutando l’esperienza di massa del “lavoro forzato da casa” non come un evento da cui estrarre, alla luce anche delle evidenze di ricerca che non sono mancate, sia gli elementi di interesse effettivamente replicabili in futuro, sia i problemi rispetto ai quali approfondire l’analisi, bensì come l’avvento, quasi messianico, di una rivoluzione organizzativa (resa però possibile innanzitutto dalla tecnologia, tema su cui torneremo nel secondo articolo) di cui il lavoro in Italia aveva (ed ha) bisogno. Non era vera né la prima, né la seconda affermazione.
L’osservazione di quanto realmente accaduto, liberata dalle narrazioni e dalle retoriche, ci restituisce invece un quadro decisamente più sfaccettato. Come anche un’ampia ricerca psico-sociale effettuata nel mese di aprile dall’Università Cattolica, su cui torneremo, ha mostrato, il lavoro da casa, nelle condizioni in cui s’è svolto, non è stato affatto smart (o almeno, non lo è stato per tutti).
Se da un lato la contestuale chiusura forza delle scuole e delle università riempiva le case di figli non sempre dotati del sufficiente grado di autonomia per liberare i genitori dalla necessità di un loro controllo, dall’altro sono emersi tutti i deficit tecnologici (di strumenti, di connessioni, di formazione) che la più grande operazione di dislocazione fisica del lavoro mai sinora effettuata ha fatto emergere con impietosa evidenza. Certo, non può sottacersi che nel giro di qualche settimana sia accaduto qualcosa che solo il mese prima era a dir poco impensabile. Ma questa impressionante evidenza non può essere di per sé sufficiente per decidere sull’inoppugnabile bontà dell’accaduto: al contrario, dovrebbe spingerci in modo (in questo caso certamente) più “agile” a mettere sotto le lente di ingrandimento le rilevanti criticità subito esplose nei milioni di “case-uffici” che l’emergenza ha pressoché istantaneamente e letteralmente creato dall’oggi al domani.
D’altra parte la costruzione retorica e narrativa di questa nuova realtà era già stata attivata da tempo. Negli anni precedenti la pandemia (diciamo almeno da un paio d’anni prima della legge 81/2017 che ha disciplinato questa prassi) il florilegio di articoli e interviste che decantavano un mondo fatto di lavoratori dispersi in mille luoghi diversi si è riprodotto in maniera esponenziale. In questa enorme massa di prese di posizione – tutte entusiasticamente a senso unico – stavano anche (e pour cause) quelle degli esperti della materia, ossia di coloro che lo smart working lo conoscevano bene intendendolo come prassi d’innovazione organizzativa da associare ad un necessario sottostante (e preventivo) cambiamento di paradigma gestionale dell’impresa al quale poi ascrivere, come effetto, una vera e propria rivoluzione (nel quadro, perfettamente coerente, di quella “grande trasformazione” del lavoro che una serie di fenomeni sociali e tecnologici stava e sta tuttora realizzando).
Il tutto senza dimenticare il fatto, però, che fino a quel punto e nonostante il grande battage informativo (fatto anche di decine di convegni e di qualche libro a tema), almeno qui in Italia, ben poche realtà si erano determinate al “grande salto” rimasto, così, associato all’esempio di alcune multinazionali e qualche grande “firma” nostrana. Tutte però portate in palmo di mano come esempi viventi del “si può fare!” sottovalutando, forse, l’ostacolo costituito dalla “taglia” e dalla dimensione culturale media della nostra media impresa: piccole, entrambe.
Ecco: “si può fare!” Gli amanti del cinema ricorderanno che proprio questa era l’esclamazione urlata dal grande Gene Wilder in un mitico ed indimenticabile film del 1974: Frankenstein Junior. Nel film essa sottolineava la “scoperta” che sarebbe stato possibile restituire alla vita un essere umano morto da poco (1) e ciò semplicemente cambiando “i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo”. Si tornerà più avanti sul senso di questo richiamo.
Luca Pesenti Giovanni Scansani
*Luca Pesenti, professore associato nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
**Giovanni Scansani, co-founder Valore Welfare Srl
- “Finché dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò, una luce così brillante e portentosa eppure così semplice: cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo… Io, solo io, sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, macché, anche di più: io, proprio io sono divenuto capace di rianimare nuovamente la materia inanimata…si può fareeeee!!”



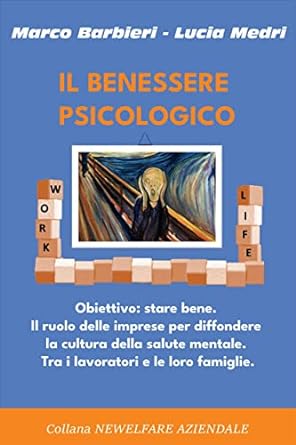












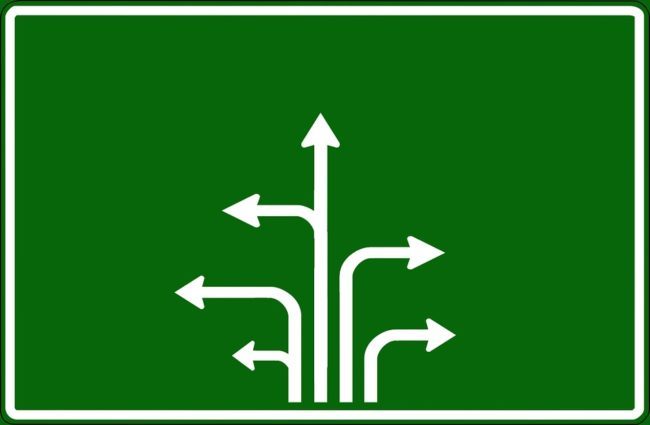




Welfare aziendale: la scenario italiano. Intervista a Marco Barbieri
Luglio 12, 2024