Tra “piano Colao” e “Family Act”: il futuro del welfare aziendale potrebbe (o dovrebbe?) incrociare i bisogni e le esigenze delle famiglie, sempre più primo ammortizzatore sociale del Paese. Un contributo di Mariano Delle Cave, Luca Pesenti e Giovanni Scansani.
Oltre alle necessarie tutele rivolte alla conservazione dei posti di lavoro – fin quando ciò potrà durare nella lunga Fase2 della pandemia – si stanno già ora facendo pressanti anche altre istanze alle quali dover fornire una corretta risposta. O almeno una “cornice” di riferimento, se si vorrà rimettere “in bolla” la relazione, fattasi ancor più complessa, tra le esigenze della vita privata e quelle della vita lavorativa. Entrambe queste sfere, infatti, ed in molti casi, sono state letteralmente travolte dal “lavoro da remoto forzato” (impropriamente definito “agile” dalla legislazione emergenziale e smart working nel dibattito pubblico).
Senza poi dimenticare che a tali criticità, per molti nuclei familiari e singoli lavoratori e lavoratrici, si aggiunge anche la significativa riduzione del potere d’acquisto conseguente alla riduzione salariale derivante dall’applicazione degli ammortizzatori sociali. Una dinamica che non farà che peggiorare quanto già segnalato dall’ISTAT rispetto alla fine del 2019, quando fu registrata una contrazione del potere d’acquisto delle famiglie pari al -0,4%.
La famiglia, vero “capitale sociale” del Paese
Quella “cornice” di riferimento non dovrà prescindere dalla considerazione del ruolo svolto dalla famiglia, tuttora capace di esprimere la sua funzione di principale ammortizzatore sociale e che deve tornare ad essere anche il motore demografico, senza il quale il nostro Paese è destinato ad un’inesorabile decadenza. La dura fase di lockdown che tutti abbiamo sperimentato ci restituisce ancora una volta l’immagine di un Paese in cui, al di là delle retoriche, buona parte del peso del sistema di welfare ricade proprio sui nuclei famigliari. Ed è proprio la famiglia ad aver sostenuto il peso maggiore, dovendo “contenere” al tempo stesso le tensioni derivanti dalla contemporanea deprivazione psicologica della libertà, dalla chiusura delle scuole (non a caso i nuclei in maggiori difficoltà sono stati quelli con figli sotto i 5 anni, come conferma anche una ricerca dell’Università Cattolica cui ha partecipato uno degli autori di questo articolo), dalla remotizzazione forzata del lavoro, dalla preoccupazione per un futuro denso di incertezze e potenziali pericoli. Eppure, la stessa ricerca dell’Università Cattolica ci segnala che se da un lato lavoratori e lavoratrici hanno faticato (e non poco) per reggere i ritmi lavorativi e gli equilibrismi conseguenti, dall’altro hanno fatto emergere una generalizzata percezione di miglioramento nell’ambito delle relazioni famigliari. Confermando, se ce ne fosse stato bisogno, che proprio queste relazioni sono il primo “capitale sociale” che permette a una società di sostenere anche i periodi più difficili.
Come tutte le altre forme di “capitale sociale”, anche le famiglie non si creano per legge ma hanno bisogno di una normativa che le aiuti a svilupparsi. Il rischio, altrimenti, è che deperiscano nella generale disattenzione.
Decidere di “fare famiglia”, e dunque di mettere al mondo (o di adottare) dei figli, è un’intima e personalissima scelta associata, in primis, alla struttura culturale e valoriale dei soggetti e delle comunità di riferimento. Come tanti casi internazionali dimostrano, non ci sarà nessuna legge, neppure la migliore possibile, capace da sola di dare più forza al desiderio di costruire nuove famiglie e di mettere al mondo più figli. E tuttavia, l’infrastrutturazione dei servizi (pubblici o aziendali che siano) che oggi il “Piano Colao” intende rafforzare potrebbe essere un utile contributo per dare forza ad un processo sociale ed antropologico complesso, che potrà portarci a famiglie più solide e più aperte alla generatività. Riconoscendo come “bene pubblico” ciò che oggi è stato semplicemente trattato come “bene privato”. La famiglia non è infatti solo procreazione, ma è anche capacità educativa, stimolo del desiderio, “cellula” di redistribuzione di diritti e doveri, palestra di socialità, cura degli anziani genitori, spesso non autosufficienti, o di soggetti disabili. Proprio per questo, ci sembra che il deficit di risposte del welfare pubblico alle domande sociali che salgono da questo soggetto sociale sui generis (ad esempio, attraverso la continua attività di lobbing messa in campo dall’attivissimo “Forum delle Associazioni Famigliari” sotto la guida di Luigi De Palo) si palesa nella carenza di soluzioni e nel far conto implicitamente ed esclusivamente sull’accudimento dei soggetti vulnerabili reso da un caregiver informale, ossia un familiare (che poi è generalmente una donna che, con buona frequenza, è anche impegnata nel lavoro, quando non è costretta a lasciarlo come capitato nel 2019 a 37mila di loro). Ecco, proprio su questi aspetti ci sembra che nelle proposte più recenti ci sia un vuoto sorprendente, soprattutto considerando che l’Italia è un Paese con una popolazione tra le più vecchie al mondo e la più vecchia in Europa. Per questo, sentiamo la necessità di avanzare le nostre proposte per dare più forza alla famiglia attraverso uno degli strumenti che ha mostrato in questi anni più capacità e duttilità: il Welfare Aziendale (WA).
Un Welfare Aziendale non solo individuale, ma familiare
Il Family Act – la recente iniziativa legislativa promossa dal Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – oltre che misure di carattere previdenziale (come l’introduzione di un assegno universale) e la revisione del sistema dei congedi parentali, promette anche di “prevedere agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello” (art. 3, co. 2, lett. h) del Disegno di Legge).
A tale proposito il “Piano Colao”, consegnato a ridosso di tale iniziativa, aveva proposto l’ampliamento degli strumenti di WA a supporto alla genitorialità, tramite la detassazione e la decontribuzione delle somme erogate a tale fine dal datore di lavoro, prescindendo dalla circostanza che fossero rivolte alla generalità dei dipendenti.
L’iniziativa legislativa potrebbe allora essere più efficace (anche sul piano della successiva contrattazione collettiva) se fosse definita (ex lege, appunto) una specifica “categoria omogenea” (nel senso fiscale ben noto) composta dai beneficiari di alcune particolari forme di WA prescindendo dall’usuale prassi della loro differenziazione economica sulla base dell’inquadramento contrattuale. L’utilizzo dei “carichi di cura” come elemento premiale aggiuntivo è stato sperimentato, anche in sede contrattuale, ancora da pochi ed isolati casi: ma proprio questi casi ci dicono che è possibile, e probabilmente una diretta esplicitazione normativa potrebbe aiutare a “fare cultura” tra un numero più ampio di imprese. La nuova “categoria” non dovrebbe essere, dunque, solo quella di matrice genitoriale, ma dovrebbe poter rappresentare tutti i lavoratori con particolari “carichi di cura” (figli minori, anziani, disabili, tenendo anche conto di condizioni come un’intervenuta separazione dei coniugi o lo stato di vedovanza) che, come tali, incidono maggiormente sul piano economico e sulle dinamiche di conciliazione vita-lavoro rispetto alle condizioni nelle quali si trova la generalità dei beneficiari dei piani di WA.
È questo un tema che le parti sociali, prima ancora del Legislatore, dovrebbero affrontare in sede contrattuale mettendo al centro degli interventi di WA i bisogni delle persone che s’intersecano con altre esigenze più generali, ancor più meritevoli di tutela, come quella dello sviluppo demografico, della parità di genere e dell’inclusione. Il tutto uscendo dal richiamato ritualismo delle semplicistiche ripartizioni del quantum da destinare al WA solitamente stabilito tenendo conto dei soli inquadramenti contrattuali.
Più è “pesante” il “carico di cura” (da comprendere e analizzare in modo più specifico di quanto non si faccia oggi), più “ricco” dev’essere il “Conto Welfare” individuale disponibile. È questa un’equazione che non ammette eccezioni, pena il tradimento della finalità stessa insita nell’attivazione delle misure di WA.
La grave crisi che abbiamo di fronte a noi aumenterà certamente le difficoltà proprio rispetto a questi cluster di lavoratori e di familiari dei lavoratori. Una diversa incentivazione normativa per gli importi allocati a titolo di WA deve poter favorire la possibilità di un loro incremento quando esso sia direttamente rapportabile alla complessità dei “carichi di cura” familiari (e non solo di quelli connessi alla genitorialità). In tal modo, a parità di inquadramento e con qualche agevole correttivo che tenga comunque conto della RAL percepita (e/o dell’ISEE), il lavoratore con figli o con soggetti anziani o disabili presenti nel nucleo familiare potrebbe ricevere un sostegno più equo.
È vero che il Family Act sembra essere indirizzato soprattutto al sostegno dello sviluppo demografico, ma l’art. 1 del DdL si propone di conciliare (in generale) vita familiare e lavoro e quindi questa finalità più generale di tutela della famiglia, non solo sul piano demografico, dev’essere la base di partenza per una corrispondente coerenza anche delle iniziative di WA.
Oltre che sul nuovo ambito soggettivo, è necessario tuttavia agire anche sul quantum.
Tra le iniziative indicate dal DdL acquistano rilievo anche quelle destinate ad “incentivare l’autonomia e il protagonismo giovanile” (art. 6) e tra queste la previsione della detraibilità fiscale delle spese “relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario”: non sappiamo se ne siamo tra gli ispiratori, ma in molte occasioni, anche ben prima della pandemia, questo è stato un aspetto d’innovazione del perimetro del welfare che avevamo più volte segnalato.
Nidi e asili aziendali
Il “Piano Colao” auspica la predisposizione di un “piano nazionale per lo sviluppo dei nidi pubblici e privati” fissando un ambizioso (ma forse irrealistico) target di copertura al 60%. È appena il caso di ricordare che, a livello nazionale, non si è neppure mai raggiunto quel 33% a suo tempo già previsto – si era nel 2010 – dalla “Strategia di Lisbona”: nel nostro Paese l’asilo nido pubblico è garantito in media soltanto a 1 bambino su 10, ma soprattutto al Sud le percentuali crollano (in Calabria e Campania la copertura è rispettivamente pari al 2,6% e al 3,6%).
Quanto alle spese eventualmente sostenute per la costruzione di nidi e asili aziendali (qualificabili come “opere” nel senso del TUIR), il cui allestimento è suggerito dal “Piano” stesso, forse si potrebbe fare una proposta più ampia rispetto alle non meglio precisate “agevolazioni fiscali” per la loro realizzazione e successiva gestione e delle quali il Family Act potrebbe in futuro tenere conto.
L’investimento finalizzato alla costruzione di quelle strutture (che oggi rappresentano, peraltro, una rarità, al di là – anche in questo caso – delle narrazioni superficiali che spesso tendono ad associare il WA proprio con gli asili organizzati dentro le pochissime aziende che se ne sono effettivamente dotate) potrebbe fruire di un trattamento contabile e fiscale similare a quanto previsto per gli “iper” e “super” ammortamenti relativi ai beni strumentali funzionali alla trasformazione ed all’ammodernamento produttivo. Nel caso in questione sarebbe premiata la compartecipazione alla trasformazione ed all’innovazione sociale (oltre che organizzativa interna dell’impresa), potendosi aggiungere qualche ulteriore incentivo laddove la struttura allestita all’interno dell’impresa metta a disposizione del territorio un certo numero di posti rendendoli così disponibili anche alle famiglie di soggetti non impiegati in azienda (l’incentivo premierebbe, così, una concreta realizzazione capace di generare shared value nel più ampio quadro del rafforzamento del “welfare mix”).
Oltre ad un supporto economico per il pagamento della retta degli asili (come prevede il Family Act) si può forse pensare ad un impianto più strutturale immaginando una o più “spinte gentili” (nudging) che, attraverso provvedimenti di cd. soft law, possano condurre, in funzione del sostegno alle nascite, alla diffusione dei casi di allestimento di asilo nido aziendali a fronte della presenza, nelle singole unità produttive, di un prefissato numero di dipendenti (senza distinzione di genere per evitare italiche manovre diversive), ovviamente ponendo a sostegno di tali interventi un robusto sistema di incentivi e di possibili finanziamenti agevolati. Entrambi, poi, potranno essere a loro volta incrementabili in funzione della ricordata possibile apertura territoriale delle strutture e della sinergia così attivabile con l’offerta locale di analoghi servizi. Analogamente e pur sempre nel quadro di policy che possano accompagnare il cambiamento e l’innovazione sociale, l’incentivazione potrebbe sostanziarsi in un sistema di sgravi laddove le aziende finanzino la costruzione di asili nido comunali nei territori nei quali insistono le loro attività produttive e vivono le famiglie dei lavoratori, realizzandosi così una concreta manifestazione di quella Responsabilità Sociale d’Impresa più volte evocata, ma non sempre associata ad azioni di reale e diffuso impatto sociale.
I Premi di Risultato dentro il Family Act
Infine, il “Piano Colao”, come noto incentrato – per la parte che qui ci occupa – sul tema della conciliazione vita-lavoro e su quello del sostegno alla genitorialità, quanto ai Premi di Risultato (PdR) ha proposto che la loro conversione in servizi di WA (se aventi le finalità ora ricordate) possa avvenire “senza i vincoli e i limiti previsti per tale conversione” dall’attuale disciplina a suo tempo introdotta con la Legge 208/2015.
La proposta, però, sembra avere il fiato corto, tenuto conto che in tema di PdR, permanendo la necessità dell’accordo sindacale, una fetta cospicua di aziende (ed una ancor più rilevante quota di addetti) resterebbero escluse da un tale scenario. La contrattazione di secondo livello, infatti, non sembra riuscire a decollare nelle PMI, da un lato perché il sindacato è scarsamente presente in queste realtà, dall’altro perché sembra resistere il tradizionale “particolarismo” individualista delle piccole realtà imprenditoriali del nostro Paese. Poco ha potuto, dunque, anche la contrattazione territoriale, alla quale il piccolo o il medio imprenditore preferisce non accedere proprio per tenere a distanza il sindacato: secondo il più recente report sui Premi di Risultato, rilasciato dal Ministero del Lavoro a metà maggio, sono poco più di 2.500 i contratti territoriali attivi sugli oltre 11.000 attivi, con una diffusione decrescente nel corso di quest’anno, dopo i dati apparentemente incoraggianti registrati nella seconda metà del 2019 (e peraltro non sappiamo quante aziende li abbiano, alla prova dei fatti, poi effettivamente sottoscritti).
Un’alternativa che potrebbe fare propria il Family Act, anche solo temporaneamente (ossia prevedendola per il solo periodo necessario al “rilancio” del lavoro e della nostra economia e quindi sostenendo le famiglie che della tenuta sociale e di qualsivoglia “rilancio” sono sempre un brano essenziale), potrebbe essere quella di consentire la definizione dei criteri di assegnazione del PdR – fruendo della relativa disciplina di favore (eventualmente potenziata nel senso voluto dal “Piano Colao” laddove la conversione si concentri sui servizi di conciliazione vita-lavoro a sostegno della genitorialità) – rendendo possibile il deposito anche solo di un regolamento aziendale, purché dotato delle caratteristiche a suo tempo precisate dall’Agenzia dalle Entrate (ossia avente valenza negoziale). Si tratta del resto, di uno strumento già equiparato dal TUIR al contratto collettivo quanto agli effetti del favor fiscale che sostiene le iniziative di WA.
Ma sull’intera questione dei PdR – prima ancora d’immaginarne una specifica finalizzazione “genitoriale” laddove convertiti in specifici servizi di WA – aleggiano, sinistri, i devastanti effetti economici della pandemia.
Non è difficile immaginare che buona parte delle aziende, nel 2021, non saranno nelle condizioni di erogare il PdR agganciato ai risultati conseguiti nel corso del 2020 e ciò, semplicemente, perché quei target non potranno essere raggiunti a causa della caduta verticale di ricavi e profitti causata dal “fermo” generalizzato delle attività (faranno eccezione le aziende che hanno continuato ad operare a pieno regime nel quadro delle attività ritenute essenziali).
Non dev’essere tuttavia dimenticato che è pur sempre possibile sganciare il PdR dalla logica dell’incremento dei target attivando percorsi di cosiddetto “welfare premiale” il quale – fissando pur sempre degli obiettivi come premessa per il suo riconoscimento, ma senza doversi ancorare ai criteri del Decreto Interm. del 25 marzo 2016 – potrà correlare la componente variabile della retribuzione a meccanismi di gain sharing privi dei requisiti richiesti per l’applicazione della specifica disciplina dei PdR welfarizzabili.
Certo, verrà meno la libera scelta del lavoratore che, nell’impostazione basata sul riconoscimento del PdR, aveva pur sempre la facoltà di optare per la corresponsione del premio in cash. Il WA premiale questa alternativa non può riconoscerla, ma tra correre il rischio di non ricevere nulla e la possibilità di ricevere la quota variabile dello stipendio, sia pure integralmente e solo in kind (e quindi in WA, ossia in beni e prestazioni dei quali comunque il lavoratore avrebbe bisogno, per sé o per il suo nucleo familiare), la risposta appare scontata. Ovviamente il WA premiale non potrà consentire di superare i massimali stabiliti dal TUIR che, invece, il “welfare di produttività” consentiva di travalicare (quanto a sanità integrativa, previdenza complementare e azionariato diffuso), mentre resterà salva la possibilità di articolare il sistema incentivante prevedendo comunque la corresponsione di una sua quota in cash (quest’ultima sarà, però, fiscalmente trattata – per entrambi i soggetti: azienda e lavoratore – come retribuzione ordinaria e quindi sottoposta a contribuzione e tassazione ordinarie).
La possibilità di accedere a queste alternative, basate sulla considerazione che gl’indicatori previsti dal Decreto Interm. del 25 marzo 2016 sono sostanzialmente fuori gioco rispetto all’andamento produttivo del 2020 non dovrebbero spingere a bypassare l’idea di una misura straordinaria di detassazione per il 2021 per salvaguardare almeno una parte del PdR con opzione di conversione in WA. Sulla scorta di alcuni esempi aziendali che ci sono arrivati dalla martoriata area bresciana, si potrebbe allora istituire per legge un “Premio Coraggio” (che poi altro non sarebbe stato che un “premio presenza”), da riconoscere nel 2021, a tutti coloro che, nonostante il lockdown, hanno continuato a lavorare nel periodo più critico del 2020 (in azienda come da remoto). Se, come ci ha segnalato ISTAT, circa 15 milioni di persone hanno continuato a lavorare durante il lockdown, e 8 milioni di queste (la stima è in questo caso della Fondazione Di Vittorio) lo hanno fatto da casa, significa che ci sarebbe una platea di 7 milioni di lavoratori e lavoratrici cui sarebbe possibile indirizzare questo specifica formula premiale.
La misura di base ordinaria potrebbe essere di 100 euro, sulla scorta di quanto già previsto dal Decreto “Cura Italia” per lo scorso mese di marzo, aumentando tale importo fino ad un massimale più degno, soprattutto (ed anzitutto) per i lavoratori con “carichi di cura” e per quelli che non sono stati collocati in smart working in quanto addetti a mansioni incompatibili con questa modalità di esecuzione della prestazione e che quindi hanno corso, coraggiosamente appunto, un maggior rischio di esposizione al contagio, pur di consentire alle imprese di presentarsi ancora vive all’appuntamento con la ripresa.
*Mariano Delle Cave, avvocato e dottore di ricerca in Diritto del Lavoro
*Luca Pesenti, professore associato nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
*Giovanni Scansani, co-founder di Valore Welfare Srl



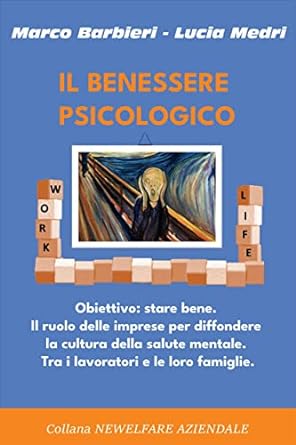
















L’educazione finanziaria potenzia il welfare aziendale
Novembre 18, 2024