Con questo articolo prosegue (seconda puntata) l’anticipazione (in otto puntate) della nuova riflessione dedicata allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Il lavoro da casa, forzatamente remotizzato a causa della pandemia, nelle condizioni in cui si è svolto (e nelle quali spesso si sta tuttora svolgendo) per molti dei lavoratori dipendenti non è certamente “agile”, né tantomeno smart.
A pagarne le conseguenze, oltre all’insorgere di nuove fonti di stress (soprattutto per le lavoratrici), è stata la produttività del lavoro. Come ha sottolineato Tiziano Treu, le esperienze che si riducono al mero decentramento del lavoro nel domicilio del dipendente “non [hanno] valore innovativo ed anzi [possono] presentare aspetti negativi, in particolare per il lavoro delle donne e per la vita familiare”, (si veda: “La Newsletter di Nuovi Lavori”, n. 265, 2020). I dati emersi da alcune ricerche svolte “sul campo” (come, ad esempio, la “Prima indagine CGIL-Fondazione Di Vittorio sullo Smart Working” o quella curata dal “Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) lo confermano con chiarezza.
Quanto, poi, al rapporto tra SW emergenziale ed automatici (persino notevoli) incrementi della produttività, si era espresso, tra gli altri, Alberto Bombassei – patron della Brembo – che, con una lettera pubblicata dal quotidiano “La Stampa” (29.9.2020), aveva lamentato il fatto che “i benefici dello smart working sono al momento non pervenuti”. L’opinione dell’imprenditore, però, fu giudicata di parte e qualcuno fece notare che, siccome il “lavoro agile” riduce il traffico sulle strade, era ovvio che chi fabbrica sistemi frenanti per l’automotive fosse un po’ risentito.
Nessuno, però, ha replicato alcunché alle evidenze pubblicate dall’OECD-LEED nel paper intitolato “Exploring policy options on teleworking” (paper n. 10, 2020). In questa analisi si era fatto notare come “telecommuting may have positive implications on productivity of creative tasks, but negative implications on productivity of dull task”. E i compiti “dull” (noiosi) sono spesso la maggior parte. Con riferimento a ricerche svolte in Giappone (patria di quella lean production sulla quale si basano le smart factory) l’OECD ricorda come i lavoratori si sentano “less productive at home than in the office”. Un’ulteriore indicazione è poi arrivata alla fine del 2020 dall’ISTAT che nel suo Report su “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19” (14.12.2020) ha evidenziato come le aziende, a causa della remotizzazione del lavoro, lamentino un differenziale negativo sulla produttività (emerso come differenza tra incrementi e decrementi dichiarati dalle imprese monitorate) che si attesterebbe al –20% (e quanto all’efficienza gestionale al –29,3%). Il campione delle aziende preso in considerazione è robusto (sono oltre un milione): qualcosa vorrà pur dire.
L’ufficio “è morto”
Il silenzio che su questi dati hanno osservato i paladini di uno SW che oggi, per lo più, tale non è, può facilmente spiegarsi: uno dei cavalli di battaglia della retorica del lavoro “da remoto” (che non è nata con il Covid-19, ma era già stata costruita da tempo: attendeva solo un’occasione per rompere gli argini) è proprio l’asserito effetto – automatico e sempre incrementale – della produttività del lavoro. È interessante notare come il differenziale negativo catturato dal citato report dell’ISTAT sia sostanzialmente pari, ma di segno opposto, a quello del preteso (ma non mai dimostrato) aumento generalizzato della produttività che lo SW determinerebbe miracolosamente, sempre e comunque, sol che lo si attivi.
Negli anni precedenti alla pandemia (ed antecedenti anche alla pubblicazione della L. 81/2017 che ha disciplinato questa prassi) il florilegio di articoli e di interviste che decantavano un mondo fatto di lavoratori felici e dispersi in mille luoghi diversi e di manager e di imprenditori non meno entusiasti di questa prospettiva, anche grazie ai ricordati (solo asseriti) incrementi della produttività così conseguibili, si è prodotto in maniera esponenziale. In questa grande quantità di prese di posizione – tutte entusiasticamente a senso unico – spiccavano anche (e pour cause) quelle dei consulenti e degli esperti della materia, ossia di coloro che lo SW lo conoscevano bene, correttamente intendendolo come prassi d’innovazione da associare ad un necessario sottostante, complesso (e soprattutto preventivo) cambiamento del paradigma organizzativo dell’impresa al quale poi ascrivere, come effetto, una vera e propria “rivoluzione” (nel quadro, perfettamente coerente, di quella “grande trasformazione” del lavoro che è in atto da tempo).
Tutto ciò, però, si produceva dimenticando il fatto che, fino a quel momento (e nonostante un grande battage informativo fatto anche di decine di convegni e di qualche libro a tema), almeno qui in Italia, ben poche realtà si erano determinate al “grande salto” rimasto, così, associato solo all’esempio di alcune multinazionali e di qualche grande “firma” nostrana.
Si trattava di poche e limitate esperienze, nondimeno portate in palmo di mano come best practice dalle quali si faceva persino discendere una certa sottintesa (ma malintesa) facilità con la quale sarebbe possibile trasformare organizzazioni e paradigmi del lavoro molto radicati, sottovalutando, tra l’altro, l’ostacolo costituito dalla “taglia” e dalla dimensione culturale media delle imprese che caratterizzano la trama del nostro tessuto produttivo ed economico: piccole, entrambe. Una condizione certamente sfavorevole ai cambiamenti di ogni tipo.
Gli apostoli del “lavoro agile” – nel frattempo moltiplicatisi già prima della pandemia – iniziavano ugualmente a dar manforte all’idea dell’avvento di una “nuova era” andando di pari passo con aziende, in realtà, spesso motivate più da finalità ascrivibili al marketing (in particolare alle tecniche di employer branding) o alle tecniche di saving (sulle spese generali) piuttosto che da una reale volontà di trasformazione della loro tradizionale organizzazione del lavoro (che tale, dunque, rimaneva).
In questi casi ai lavoratori è stato sì consentito di lavorare in un luogo diverso da quello aziendale, ma pur sempre continuando ad operare in un contesto che, per quanto in maniera molto trendy sia stato stato definito smart, restava pur sempre impostato sulla struttura degli “uffici-fabbrica di fantozziana memoria” (come li definisce Federico Butera nel suo “Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza” – Studi Organizzativi, 1/2020).
In quelle aziende, cioè, si assisteva ad una replica – sia pure in un “altrove” – delle usuali procedure novecentesche basate sulla “burocrazia” di procedure e di regole tutt’al più frettolosamente aggiornate, ma pur sempre finalizzate a conservare gli schemi di lavoro precedenti, a partire dall’osservanza del decorso del tradizionale orario di lavoro, a sua volta tutt’altro che articolato su progetti, obiettivi e risultati misurabili (come vuole il reale “lavoro agile”) e da saturare nei termini di un lavoro “per quantità”, spesso tradottosi in una sorta di “cottimo digitale”, versione invero nuovissima del vecchissimo “lavoro a domicilio” o al più rivelatosi come una riedizione del telelavoro.
Anziché contrastare simili impostazioni anche una parte degli esperti di SW ha cavalcato gli eventi e la conseguente onda mediatica finendo, così, per accettare il mantra di un’ormai prossima e definitiva affermazione di un lavoro “senza luogo” (quindi letteralmente utopico) o comunque non più collocato nel luogo “cattivo” della costrizione espressa dalla prestazione “in presenza” da rendere in ufficio (“l’ufficio è morto” o al massimo serve solo per qualche incontro ogni tanto) e finalmente eseguibile da altri luoghi più “buoni” (quindi eutopici): al mare o ai monti e magari collegandosi (chissà poi grazie a quali infrastrutture di rete), da antichi e remoti borghi così, finalmente, riscoperti e ripopolati grazie all’arrivo in massa degli smart workers.
Alla pretesa “morte dell’ufficio” il settimanale “Internazionale” ha dedicato la cover story del numero del 3/9 luglio 2020 ed un’ampia rassegna di interventi. Tra questi c’è quello di Catherine Nixey (“Death of the office”) che, dopo aver proceduto ad un excursus della storia dell’ufficio – a partire da quello londinese della Compagnia delle Indie – perviene alla conclusione che “Humans need offices (…) because what moves us is not sitting at our computer, it’s the relationship that we have with people”.
Questa è anche una delle evidenze emerse dalle survey effettuate da Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) durante il lockdown (aprile 2020) ed anche successivamente (luglio 2020). Dal documento riassuntivo di queste ricerche (“Living, working and Covid-19”, 2020), emerge con chiarezza che “the preferred teleworking arrangement for most respondents still involves a significant continuing presence at the workplace”. L’ufficio è vivo: si tratta semmai di “cambiarlo”, non di sotterrarlo.
Borghi ameni e impiegati flâneur
Quanto alla possibilità di lavorare “dove si vuole” (riscoperta dei borghi inclusa) basta rilevare che questi scenari più volte evocati si scontrano con il dato testuale della stessa normativa applicabile al “lavoro agile”. Un’insindacabile e completa autonomia del lavoratore nella scelta del luogo in cui rendere la prestazione all’esterno dell’azienda è impensabile perché – come vuole la legge – esso deve rispondere sia a criteri di ragionevolezza (che tengano conto, ad esempio, della necessità di dover rientrare in sede in tempi non meno ragionevoli, ove ciò sia necessario), sia all’evidenza che tale scelta non può finire per rendere estremamente difficoltoso (per non dire impossibile) al datore di lavoro garantire le tutele in materia di sicurezza, tant’è che i diversi luoghi nei quali la prestazione lavorativa può essere resa sono normalmente concordati con il datore di lavoro stesso (anche al fine, per quest’ultimo, di poter esercitare il potere di accesso di cui all’art. 3, c.10, D.Lgs. 81/2008). Ciò se da un lato comporta il ridimensionamento della flessibilità logistica della prestazione, dall’altro rappresenta una soluzione coerente con il fine di assicurare la tutela prevenzionistica per il lavoratore “agile” il quale è, per di più, tenuto ad un obbligo di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi.
Allo scenario di un lavoro reso “dove si vuole”, si è associata anche l’idea, vagamente new age, di un lavoro che, senza considerare il necessario coordinamento con l’attività aziendale complessiva, sia anche “senza tempo” perché svolto “quando si vuole” e dunque non cronofagico rispetto alle proprie necessità personali e al proprio lifestyle perché articolato su un soggettivo orario di lavoro, secondo il proprio personale ritmo circadiano (scenario indubbiamente affascinante e per certi versi coerente con la logica “agile” di un lavoro davvero smart, tuttavia – per la maggior parte dei lavori che possono svolgersi “in remoto” – alquanto irrealistico se portato alle sue estreme conseguenze).
Alla libertà del “dove” e del “quando” lavorare si è poi aggiunta l’idea di un lavoro che si potrebbe svolgere anche “come si vuole”, ossia non più secondo criteri ormai stantii e sulla base di ritmi e “paletti” stabiliti da altri (il datore di lavoro o il manager cui si riporta o il team con il quale si collabora) perché – come sostiene Domenico De Masi – se in ufficio anche la figura impiegatizia assomiglia, in fondo, al metalmeccanico del Charlie Chaplin di “Tempi Moderni” ora, con lo SW, essa “confina con quella del flâneur di Baudelaire” (la vivida immagine che suscita questo richiamo ci fa pensare, fuor di metafora, che sia tutta da verificare la disponibilità delle imprese anche solo a poter immaginare di remunerare un impiegato flâneur per scovare il quale, oltretutto, la misurazione delle prestazioni sulla base dei risultati ha proprio nello SW un suo buon alleato).
Arrivare impreparati rispetto a questa “rivoluzione” – tale il messaggio trasmesso dai sostenitori di uno SW sganciato dalle sue complesse premesse di riprogettazione organizzativa – per le imprese significherebbe perdere il contatto con la realtà e con gli avanzamenti nel frattempo realizzati dai concorrenti (tutti ovviamente sempre definiti già smart working oriented) che potranno, così, ampliare il loro vantaggio competitivo anche stornando alle aziende ritardatarie i collaboratori più insoddisfatti e quindi ben felici di andare a lavorare in realtà dove, al contrario, lo SW è parte rilevante di un più stimolante total rewarding. Quest’ultima circostanza è peraltro realistica, ma come abbiamo già detto, essa il più delle volte si associa non all’autentica prassi di un reale “lavoro agile”, ma al marketing associato agli obiettivi di employer branding (quando non a quelli della realizzazione di saving sul costo del lavoro e sulle spese generali di sede).
Welfare Aziendale e Smart Working
Nella fase ante pandemica si affermavano anche le narrazioni che miravano a diffondere il Welfare Aziendale (anch’esso in parte mitizzato) nel cui ambito, tuttora, è spesso fatto ricadere lo stesso SW inteso come un’efficace misura di conciliazione vita-lavoro. È questo un assunto di cui può riconoscersi l’esattezza solo laddove si consideri che i positivi impatti sul work-life balance saranno al più l’effetto, ma non la motivazione per cui il reale SW viene adottato (e sempre che in sede di contrattazione sia stato individuato un corretto sistema di pesi e contrappesi tra esigenze produttive ed esigenze personali in grado di evitare il rischio, tutt’altro che ipotetico, di una “conciliazione ingannevole”, come la definisce un’attenta giuslavorista come Anna Rita Tinti).
Su quest’ultimo aspetto è appena il caso di rilevare che l’art. 19 della L. 81/2017 prevede la facoltà di recesso – e senza una ragione giustificatrice – dall’accordo individuale che istituisce lo SW (quando questo sia a tempo indeterminato). Questa condizione – pur dovendosi rispettare un termine di preavviso – potrebbe rivelarsi assai penalizzante proprio rispetto alle esigenze di conciliazione vita-lavoro ed in particolare per quelle dei lavoratori (spesso lavoratrici) che siano anche caregiver e per i quali la prevedibilità dei cambiamenti del modello o dell’organizzazione dell’orario di lavoro è particolarmente importante.
Tanto il Welfare Aziendale che lo SW, sempre nella fase antecedente alla pandemia, ricevevano anche una serie di endorsement di tipo normativo che ne favorivano lo sviluppo (il secondo arrivando anche a disporre di una disciplina legale ad hoc). Con una grande differenza, però: il primo “istituto” risale concettualmente ed operativamente a molti decenni or sono (il Welfare Aziendale, per come lo conosciamo ancora oggi, nasce nel pieno della prima industrializzazione italiana tra gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso e può contare sul solido retroterra rappresentato dalla storia delle conquiste sindacali e dall’evoluzione della cultura imprenditoriale più “illuminata”: dal paternalismo d’impresa alle attuali teorie sul benessere organizzativo ed individuale), mentre il secondo è molto più recente ed ha una matrice statunitense, dunque tipica di culture organizzative diverse dalle nostre, ancorché da noi velocemente e forse talvolta frettolosamente importate (è del resto proprio negli USA che viene inventato l’antecedente logico dello SW: il telelavoro). Questa diversa collocazione temporale ci dice che mentre il Welfare Aziendale ha solide radici culturali e non deve temere eventuali sbavature nella sua interpretazione (nel cui corretto alveo sarebbero prontamente ricondotte), il secondo deve ancora farsi le ossa e necessita, invece, di grande attenzione perché si sviluppi con una sana e robusta costituzione come merita. Questa attenzione “clinica” – fatte salve rarissime eccezioni – è sin qui decisamente mancata, come potremo osservare nelle prossime puntate.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



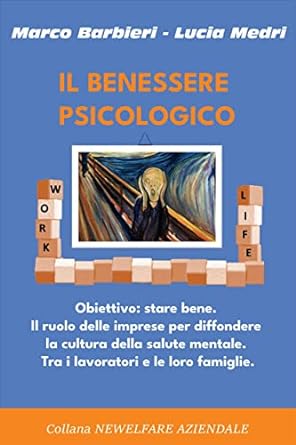













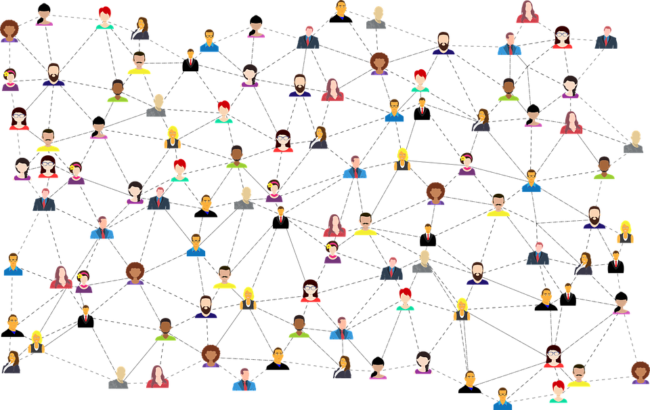


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025