Pubblichiamo i risultati de “Il mondo cambia pelle? XXIII Rapporto sull’economia globale e l’Italia”, evento tenutosi lo scorso 21 gennaio e promosso dal Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, Assolombarda e UBI Banca.
1. Un quadro generale
L’economia globale sta rallentando. Le cause non sono solo economiche. La globalizzazione degli
ultimi decenni ha prodotto molto, distribuendo male i suoi risultati. Nell’economia, si sono polarizzate
le posizioni economiche dei ceti sociali, con pochi dotati di redditi molto ampi e molti limitati a redditi
bassi con potere d’acquisto stagnante o in diminuzione e con la conseguente contrazione del ceto
medio. Nelle industrie, si sono aperte differenze tra poche imprese sempre più grandi cui la
globalizzazione ha offerto non solo ampi mercati ma anche mezzi per ridurre o scampare il carico
fiscale e molte imprese più tradizionali. Nella politica, i partiti e le élite tradizionali sono stati messi
sotto scacco dai “populismi”. Nelle politiche commerciali, Donald Trump ha dato attuazione a un
programma protezionistico, formalmente in difesa dell’America e del suo lavoro, che, pur non toccando
i movimenti di capitale, è andato a sostituire con accordi bilaterali il precedente modello basato sugli
accordi multilaterali. È come se gli effetti collaterali della globalizzazione, mai a sufficienza controllati
dai governi, si fossero palesati, cumulandosi, negli ultimi anni e, nel 2018, avessero avuto
un’accelerazione notevole, con significative “frane” nella politica tradizionale, colpevole di non aver
visto i problemi che stavano emergendo e di non aver reso sostenibile il modello di capitalismo che li
determinava.
2. Gli Stati Uniti
Formalmente protagonista della scena mondiale, l’economia americana ha tuttavia preso a scricchiolare.
La ripresa, una delle più lunghe della storia della congiuntura americana, è anche quella meno intensa,
ossia con la minima crescita media annua del Pil. Crescendo a du
ma intanto anche negli Stati Uniti nascono nei partiti ufficiali i movimenti favorevoli all’introduzione
del reddito universale di base.
3. L’”annus horribilis” dell’Europa
Mentre gli Stati Uniti cercano di ristabilire un primato economico nel mondo, faticando però non poco
nell’equilibrio interno del loro sistema, l’Europa ha attraversato nel 2018 un anno orribile, che potrebbe
non essere il peggiore se le attuali tendenze continuano.
Le proteste in Francia, la difficile negoziazione di una Brexit che non presenta scenari favorevoli in
qualsiasi caso essa si risolva, la crisi dei migranti e la continua demonizzazione delle politiche di
Bruxelles da parte dei crescenti populismi fanno da sfondo a un’economia dalle prestazioni non
esaltanti, largamente affetta dagli squilibri interni della domanda dovuti ai record commerciali tedeschi,
con una produttività che cresce meno rapidamente del passato perché l’Europa non riesce a
trasformare in innovazioni e imprese commerciali la propria produzione scientifica, di quantità e
qualità paragonabile a quella americana. Inoltre, con la bassa crescita l’unico modo di tenere sotto
controllo i bilanci pubblici è l’austerità, che, quasi ovunque, ha prodotto o produce carenze delle
infrastrutture e tagli o sofferenze allo Stato sociale. La vulnerabilità dell’Europa ha due ulteriori
dimensioni, meno conosciute: la prima è il sistema bancario, che sotto la redditività modesta potrebbe
celare non tanto la inadeguatezza patrimoniale, messa a posto dopo la crisi dei NPL, quanto la
debolezza e la lentezza delle banche a rispondere alle sfide del cambiamento tecnologico, che stanno
rendendo rapidamente obsoleto il tradizionale modo di esercitare l’attività bancaria, rispetto alle più
agili fintech e all’interesse, ormai non più celato, dei colossi di Internet di avere una fetta del lucroso
mercato dei servizi finanziari. La seconda vulnerabilità, tra le più gravi, è la demografia europea,
sintetizzabile nell’elevato e crescente quoziente di dipendenza della popolazione anziana rispetto alla
proporzione ridotta di lavoratori e lavoratrici. Per un continente che ha fatto dello Stato sociale una
delle sue caratteristiche identitarie, l’invecchiamento della popolazione comporta aggiustamenti e
riforme strutturali non facili da comunicare, meno ancora da digerire, come dimostra la diffusione quasi
uniforme dei diversi movimenti di protesta, sotto l’influsso dei quali gli elettori si accingeranno, nel
2019, ad eleggere il nuovo Parlamento europeo.
Anche i mercati del lavoro palesano dati e trend in più o meno apparente incongruenza. Nei paesi
OCSE il tasso medio di occupazione, (ossia il rapporto tra gli occupati e la popolazione nella classe di
età 20-64 anni), si è attestato nel 2017 al 72,1 per cento, due punti in più rispetto al 2006, mentre in
Italia risulta stabile al 62,3 per cento. Più contradditori appaiono i dati relativi al tasso di
disoccupazione, in moderato calo a livello OCSE dal 6,3 al 5,9 per cento, che segnalano in Europa una
forte divergenza tra i paesi del blocco continentale a trazione tedesca e i paesi affacciati sul
Mediterraneo. La solo apparente contraddizione tra tassi di occupazione stabili o in crescita e tassi di
disoccupazione che non seguono la stessa tendenza positiva – una condizione che accomuna all’Italia
altri paesi come la Spagna, la Grecia, il Portogallo e, meno scontati, la Francia, alcuni paesi scandinavi,
l’Irlanda – è da ricondurre al fatto che quote consistenti di inattivi disponibili a lavorare (quindi non
computati come disoccupati) stanno tentando di rientrare nel mercato. Questa incoerenza spiega perché
molti osservatori internazionali (oltre all’OCSE e all’ILO, anche la BCE) abbiano iniziato ad utilizzare
indicatori complementari in grado di rappresentare il reale stato delle cose.
4. Il lavoro
Il tasso di sottoutilizzazione del lavoro, che somma alle persone disoccupate anche quelle inattive e gli
occupati part-time “involontari” (ossia quelli disponibili ad aumentare l’orario di lavoro), si è attestato
nei paesi OCSE al 28,1 per cento (+1,3 per cento rispetto al 2008): ciò significa che la quota di persone
sottoutilizzate rappresenta quasi un terzo della popolazione in età da lavoro (in Italia sono il 43,9 per
cento). Lo status che ha maggiormente concorso alla crescita del tasso di sottoutilizzazione è la
diffusione del lavoro part-time involontario. La quota di occupati dipendenti che si trovano in questa
condizione è aumentata nei paesi OCSE di almeno un terzo, dal 3,2 per cento del 2006 al 4,3 per cento
del 2016. Le ragioni del maggior ricorso del lavoro a tempo parziale sono molteplici: la persistente debolezza della
domanda, l’aumento della partecipazione femminile alle forze di lavoro (che, in assenza di politiche e
servizi a supporto della conciliazione, può determinare un ricorso forzoso all’orario ridotto), la
contrazione dell’occupazione nei settori industriali (in cui è più frequente il ricorso al tempo pieno), e
l’espansione dei servizi (ad esempio il turismo e i servizi personali, in cui la flessibilità di orario è molto
diffusa). Un altro fattore meno esplorato dal lato della domanda, che in futuro potrebbe acquisire
maggiore importanza, è connesso all’accresciuta capacità delle imprese di organizzare, quantificare e
monitorare la prestazione lavorativa. La diffusione delle tecnologie digitali – dai software gestionali alla
workforce analytics – stanno spingendo le aziende ad abbandonare la logica “forfetaria” dell’orario di
lavoro full-time e a richiedere una prestazione più “precisa”. Per questo motivo, la riduzione di questo
status occupazionale appare improbabile anche in un quadro di relativa ripresa economica e, al
contrario, non è azzardato immaginare che l’impiego a tempo parziale potrebbe costituire il “newnormal” del mercato del lavoro del futuro.
Per quanto riguarda le retribuzioni, l’analisi di lungo termine segnala, nonostante la ripresa, un evidente
declino della velocità di crescita tra il periodo precedente alla crisi (2000-2007) e quello successivo
(2013-2017). Nei paesi OCSE la crescita media annua dei salari reali (ossia tenendo conto dell’aumento
dei prezzi) è calata di circa un punto percentuale, dal 2,2 per cento del 2000-2007 all’1,2 per cento del
2013-2017. Germania e Polonia sono quasi gli unici paesi in cui si è rilevato un miglioramento
significativo. Le retribuzioni sono cresciute meno in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia e in
Italia (dallo 0,6 allo 0,2 per cento). La Grecia è l’unico paese in cui tra 2013 e 2017 si è registrata una
riduzione reale dei salari.
Questa dinamica non positiva delle retribuzioni è da ricondurre in primo luogo alla pressione dell’offerta
di lavoro, che continua ad essere intensa, come si è visto, per l’elevato livello di sottoutilizzazione del
lavoro. Una seconda risposta risiede nell’aumento molto contenuto dell’inflazione che, in particolare in
Europa, ha smorzato la tensione negoziale all’adeguamento degli stipendi. Una terza risposta deriva dal
mismatch, ossia dalla non corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro determinato anche dalle nuove
tecnologie, che impedisce a molte persone di ottenere posizioni “digitali” caratterizzate da migliori
dinamiche salariali. Una quarta risposta coincide con il rallentamento della crescita della produttività del
lavoro, che nei paesi OCSE è passata da una media annuale del 2,3 per cento nel periodo pre-crisi a una
media del 1,2 per cento negli ultimi cinque anni. L’indebolimento della produttività del lavoro è, salvo
poche eccezioni (Canada, Irlanda) un fenomeno diffuso. Negli Stati Uniti è passata dal 2 per cento del
2000-2007 allo 0,6 per cento del 2013-2017, nel Regno Unito dall’1,8 al allo 0,8 per cento, in Francia
dall’1,2 allo 0,9 per cento. E’ Interessante osservare che, per una volta, il dato tedesco non appare in
controtendenza, vista la moderata contrazione di 0,4 punti (dall’1,5 all’1,1 per cento), un dato a cui si
allineano tutti i follower , ossia i paesi economicamente più legati alla Germania.. L’Italia appare invece
stabile nella sua quasi-assenza di crescita della produttività del lavoro che mediamente resta pari a un
decimo di punto su base annua. Tra le cause che potrebbero spiegare questa tendenza, i principali
osservatori hanno prestato particolare attenzione alle dinamiche della produttività per tipologia di
impresa, osservando come la crescita della produttività del lavoro si registri principalmente nelle
imprese di medio-grandi dimensioni più innovative e tecnologicamente avanzate. Un’altra ipotesi meno
esplorata, almeno in Europa, si concentra sul rapporto tra tecnologia e lavoro e sulla capacità della
prima di indurre un aumento della produttività del secondo. Una ricerca della Federal Reserve ha
segnalato un significativo aumento del rapporto tra il capital deepening e l’aumento della produttività del
lavoro, passato da circa un terzo della crescita totale nel periodo 1975-1994 ai due terzi del periodo
2010 e il 2014. Questi dati segnalano come negli Stati Uniti, per assicurare una crescita della produttività
del lavoro tendenzialmente in calo, sia stato necessario un apporto in termini di investimenti in
tecnologia hardware, software e organizzativa, molto più ampio.
5. Il quadro della politica estera
Il 2018 potrebbe passare alla storia come l’anno dei vertici politici al massimo livello. Soprattutto per gli
Stati Uniti: uno strumento, secondo il loro presidente Donald Trump – che li predilige, meglio se in
forma bilaterale, per far valere più facilmente il suo strapotere geo-politico ed economico-commerciale
nel negoziato diretto –, con cui cercare di rilanciare la leadership globale di Washington all’insegna
dell’obiettivo Make America great again. Da questa serie d’incontri l’America non è però uscita molto
bene, confermando il sospetto, tra amici e rivali, che il suo predominio globale sia in declino. Del resto,
se Trump vuol rifare grande l’America, significa che non la ritiene più tale. Ma l’approccio aggressivo
scelto per conseguire questo fine non appare il più opportuno. Anche perché nel mirino statunitense,
paradossalmente, sono finiti più gli alleati che i potenziali nemici. Nato e Unione Europea, in
particolare, sono state giudicate obsolete e ostili agli interessi americani, accusa che ha ulteriormente
indebolito tali organizzazioni.
L’intera struttura della democrazia liberale – promossa dagli Stati Uniti dopo la II Guerra Mondiale
come il loro più efficace strumento di “soft power”, grazie alle istituzioni internazionali connesse, in
genere emanazione dell’Onu – è oggetto di continue erosioni sostanziali, anche se il numero di Paesi
retti da democrazie è più che triplicato, da 35 nei primi anni Settanta agli oltre 105 attuali. È però
curioso che gli attacchi più insidiosi al sistema di valori occidentali non giungano tanto dalle cosiddette
“democrature” (democrazie dai tratti autoritari, come la Russia o la Turchia) o da stati retti da autentici
sistemi dispotici (come la Cina), quanto proprio dal Paese-campione. Trump è divenuto il dichiarato
modello di tanti despoti di successo (benché in genere votati in elezioni formalmente democratiche),
piccoli e grandi come il filippino Rodrigo Duterte, il magiaro Viktor Orbán, i polacchi Jaroslaw
Kaczynski e Andrzej Duda, l’egiziano al Sisi, il brasiliano Jair Bolsonaro.
Il resto del mondo che si riconosce ancora nei valori di democrazia liberale attende con ansia che gli
Stati Uniti recuperino il concetto di multipolarità e di cooperazione con gli enti specializzati preposti a
governare la situazione internazionale, politica ed economica. Prendendo finalmente atto che il sistema
non si regge più mediante diktat elaborati a Washington secondo convenienza (sanzioni economiche,
tagli di fondi all’ONU, denunce unilaterali di trattati). Se il “sogno imperiale” di Trump è destinato a
restare tale e la concezione multipolare delle relazioni mondiali a riguadagnare, suo malgrado, sempre
più importanza, è chiaro che Washington dovrà circondarsi di alleati fedeli e convinti e non più di
vassalli politici passivi dal consenso automatico o di mercanti interessati soltanto ai suoi prodotti, armi
in testa. Sarà grazie a essi che potrà spostare gli equilibri globali a proprio favore. Ma dovrà anche
identificare bene i suoi nemici, veri o potenziali, per evitare di contrastare quelli sbagliati.
Lo scenario di fondo sembra dominato da un confronto “tripolare” con Cina e Russia (ritenuti gli
avversari più pericolosi), la cui alleanza in via di consolidamento da un ventennio è però indebolita dalla
posizione sempre più subordinata che Mosca va assumendo rispetto a Pechino e dalla consapevolezza
che, a lungo termine, la Siberia, ricca di materie prime ma quasi priva di popolazione, potrebbe essere
“divorata”, prima economicamente e poi politicamente, dalla Cina. Invece di favorire l’emergere delle
contraddizioni tra i due Paesi, cercando di portare la Russia al suo fianco – così come cercò di fare
all’inizio di questo secolo -, l’America di Trump (che pure sulla carta non disdegnerebbe un rapporto
migliore con Mosca) sembra ossessionata dall’idea di schiacciare il rinascente nazionalismo russo. Il
clima di nuova “Guerra Fredda” che si è instaurato nel mondo favorisce così il rafforzamento di una
coalizione che, per quanto innaturale, potrebbe presto sfidare su un piano paritario i residui sogni di
“potenza unilaterale” di Washington.
6. L’Italia
In questo contesto globale ed europeo, l’Italia ha attraversato il 2018 all’insegna del rallentamento. A
questo hanno concorso cause internazionali, legate al peggioramento del commercio internazionale
dovuto ai protezionismi, ma non solo. In realtà, la ripresa italiana non è stata completa, perché è iniziata
dopo il 2012, perché non ha interessato tutti i settori (per esempio l’edilizia è ancora un convalescente
debole) e perché non ha potuto essere affiancata da un’espansione fiscale significativa, come è accaduto
a tutti i paesi nel 2009-2010.
Oltre a ciò, se si cercano le cause della ripresa incompiuta, si possono citare due argomenti: il primo è
l’insufficiente investimento, sia lordo che netto (quest’ultimo negativo) in rapporto al Pil, e il secondo è
l’allargamento del divario tra nord e sud. La inappetenza per gli investimenti ha matrici multiple, che vanno
dal ritardo con cui si programmano e realizzano le opere pubbliche, il cui stato di manutenzione offre
ormai evidenze chiare in dolorosi e frequenti casi di cronaca, alla ristrutturazione del sistema
produttivo, alla difficoltà di attrarre investimenti internazionali sul territorio italiano per ragioni non
economiche ma per lo più sistemiche, dunque difficili da risolvere.
Il Rapporto di quest’anno anticipa i risultati di una ricerca sulla libertà economica nelle regioni italiane,
realizzata con una metodologia paragonabile a quella del Fraser Institute per gli Stati del mondo. La
ricerca evidenzia come anche in questo campo (libertà, legalità, competitività) il divario Nord-Sud sia in
quasi tutti gli indicatori di tipo economico-sociale, portandosi a livelli estremamente elevati. Le
dimensioni qualitative dello sviluppo, se a lungo trascurate, producono effetti reali, che vanno
dall’emigrazione dei ceti produttivi all’aumento della domanda di sussidi e benefici pubblici: due
tendenze che sono state ben visibili nel Mezzogiorno italiano nel 2018.
Per concludere il quadro italiano, la situazione di finanza pubblica con bassa crescita del Pil è
decisamente delicata. La manovra finanziaria del 2019 ha puntato su una deviazione controllata dal
percorso di rientro nei parametri del patto di stabilità per sostenere i consumi, in particolare dei meno
abbienti. Se il principio può essere condivisibile (rispetto alla media europea, il rischio di povertà in
Italia non è sceso nella ripresa quanto negli altri Paesi), la modalità di realizzazione lascia più di un
dubbio, sia per la volontà di istituire uno strumento nuovo, da realizzare daccapo (il reddito di
cittadinanza), con caratteristiche simili al reddito di inclusione, che sostituisce e che aveva il pregio di
essere esistente, dal punto di vista amministrativo e, quindi, attuativo, ed anche idoneo ad essere
potenziato. In secondo luogo, la manovra avrebbe potuto ed avrebbe dovuto concentrarsi sugli
investimenti, e in particolare sugli investimenti infrastrutturali, sia per il ritardo che l’Italia ha, sia per il
potere di questi di propagarsi nel resto dell’economia. Con bassi investimenti infrastrutturali, non si
rimedia, neppure in parte, alla crisi degli investimenti che sta limitando la crescita del Pil e continuerà a
limitarla nel 2019. Alla fine del 2019, se i conti non torneranno, è possibile che le imposte indirette
(l’Iva) debbano essere obbligatoriamente aumentate. Se e quando accadrà, ciò avverrà nel solito
contesto fiscale italiano, caratterizzato da un’alta pressione fiscale media, malamente distribuita a causa
della rilevante evasione. La manovra aumenta le fiscal expenditure, ossia il costo fiscale delle agevolazioni
ad hoc, e cerca di scontare le evasioni del passato senza porsi il problema strutturale di come migliorare
efficienza e giustizia del sistema tributario in prospettiva. Nell’era di Internet e degli intermediari
finanziari informatizzati, si potrebbe migliorare il sistema tributario con due mosse: la riduzione del
contante (realizzabile anche incentivando l’uso del denaro elettronico) e la sostituzione delle imposte sui
redditi con imposte sui cash flow, più tempestive e sicure, probabilmente più capaci di raccogliere il
gettito e dare fiato, in prospettiva, a un fisco più equo e, finalmente, anche moderatamente più leggero,
per tutti.
7. Conclusioni
Tutto ciò può dare al lettore un senso di vertigine per il venir meno di punti di riferimento fissi, di
ideologie e religioni fortemente condivise. Come se ne esce?
L’unica soluzione che sta davvero prendendo corpo è rappresentata dalla sostenibilità. La sostenibilità
rappresenta una «chiave di lettura» sempre più largamente condivisa che si estende dal livello personale
al livello planetario. .E diventa un «sostituto delle ideologie» nella faticosa ricerca di un sistema di
dialogo del futuro.
Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Come dice un proverbio degli indiani
d’America che abbiamo scelto come epigrafe delle conclusioni: Noi non ereditiamo la Terra, la prendiamo a
prestito dai nostri figli.
Il concetto di sostenibilità implica, tra l’altro, solidarietà tra generazioni (sistemi pensionistici
sostenibili); solidarietà all’interno delle generazioni, con redditi e salari minimi tesi a ridurre, mediante
meccanismi di redistribuzione, i divari di reddito e di consumi superiori a livelli comunemente ritenuti
inaccettabili. Dalla sostenibilità passiva (limitazione o annullamento dell’inquinamento e altri danni
ambientali) si sta passando alla sostenibilità attiva (ricostituzione di un ambiente sostenibile) anche con
meccanismi di economia circolare. Questa appare l’unica risposta valida alla confusione presente.



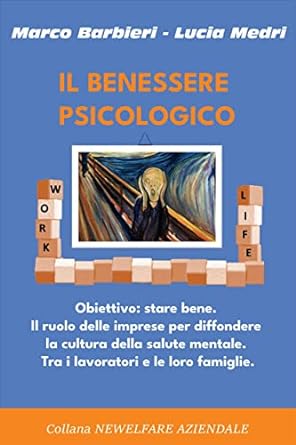












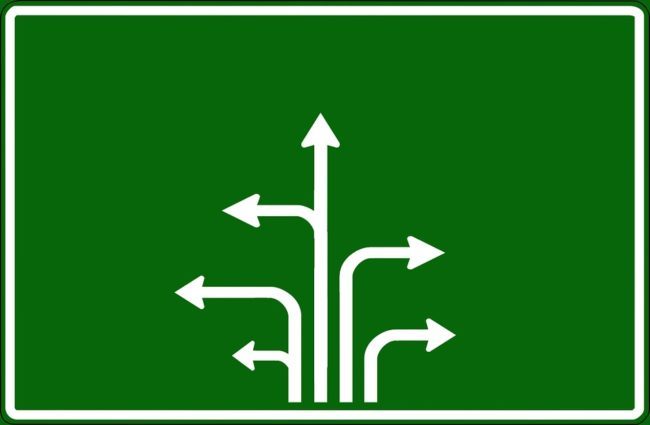




Welfare aziendale: la scenario italiano. Intervista a Marco Barbieri
Luglio 12, 2024