Dal “lavoro da remoto forzato” alle nuove modalità organizzative del post-pandemia. Un approfondimento curato da Giovanni Scansani e Luca Pesenti apparso anche su AboutPharma
Il lavoro, sùbito dopo la salute, è l’argomento principale del dibattito sulle conseguenze della pandemia. L’aspetto più discusso (ed ancora molto confuso) è quello della sua remotizzazione che la pandemia ci lascerà come stabile eredità.
Durante il lockdown, ad eccezione di coloro che sono stati posti in cassaintegrazione dall’emergenza e dei lavoratori rimasti “sul pezzo” perché impiegati in settori essenziali, tutti gli altri sono stati i protagonisti della prima improvvisa (e spesso improvvisata) esperienza planetaria di digitalizzazione di massa. Nella stragrande maggioranza dei casi non si è trattato di smart working (SW) propriamente detto, bensì di una collocazione in “lavoro da remoto forzato” che, nel giro di qualche giorno, ha trasformato milioni di case in “uffici” ed altrettante persone in lavoratori solo nominalmente “smart”.
In Italia, tra il lockdown e la “Fase 1”, il lavoro da remoto avrebbe riguardato otto milioni di persone (la stima è della Fondazione Di Vittorio), che grazie alla tecnologia disponibile hanno potuto letteralmente salvare moltissime imprese e (almeno per ora) anche il proprio posto di lavoro. Facile darsene conto: se Covid-19 ci avesse sorpreso anche solo un decennio fa, quando smartphone e connessioni internet veloci non esistevano ancora, adesso staremmo raccontando un’altra (e ben più drammatica) storia.
SMART WORKING EUPHORIA
Questa esperienza di massa ha fatto ritenere ai convinti sostenitori dello SW che fosse finalmente arrivata l’ora che essi tanto attendevano: quella della diffusione, anche in Italia, della tanto sperata trasformazione del lavoro sulla base di un nuovo, liberatorio ed innovativo paradigma organizzativo.
L’euforia (presto fattasi anch’essa di massa, almeno a livello di opinione pubblica mainstream) ha così indotto all’uso (rectius: all’abuso) del termine “smart working” pur a fronte della mancanza delle sue più elementari premesse. Prima fra tutte proprio quella libertà nella scelta di tale modalità di lavoro che la legge che lo disciplina incardina nella necessità di un accordo individuale teleologicamente votato anche alla creazione di migliori equilibri tra vita e lavoro.
Oltre a quella premessa, però, mancava proprio anche quest’ultimo esito: la convivenza forzata imposta dal lockdown al lavoro e alla vita privata tutto poteva creare tranne che un sano equilibrio tra due sfere che, sin dall’esordio dell’epoca moderna (come insegna Max Weber), sono state sempre nettamente distinte. Queste due dimensioni dell’umano si sono invece improvvisamente trovate (con)fuse in abitazioni trasformate improvvisamente anche nelle succursali degli uffici, in condizioni spesso precarie, senza un’opportuna dotazione tecnologica e nella frequente assenza di efficienti connessioni e di condizioni “logistiche” idonee per poter lavorare efficientemente.
Non c’era (e non c’è) nulla di “smart” in una simile condizione: lo sappiamo tutti e lo sanno bene milioni di lavoratori e soprattutto di lavoratrici che hanno visto crescere i livelli di stress e spesso abbassarsi quelli dell’efficienza, della soddisfazione e della loro produttività nel quadro di una generale complicazione degli equilibri della vita delle famiglie, segnate – peraltro in moltissimi casi – anche dalla contestuale collocazione dei figli in “home schooling” (con le ormai note ricadute tecnologiche, organizzative e spazio-temporali).
Il mismatch con la realtà ed una visione ingannevole fondata su un determinismo (molto semplicistico) ha finito per attribuire al coronavirus il ruolo del disruptive innovator capace di far discendere dalla crisi che ha innescato anche l’avvenuto compimento di una “rivoluzione” dalle irreversibili conseguenze (“smart working sempre e per sempre”; “l’ufficio è morto”).
L’euforia è stata poi amplificata dai media e dai social, presto invaghitisi di futuribili visioni sulle smart city liberate dal traffico, dall’inquinamento, dallo stress (e anche, andrebbe aggiunto, da migliaia di posti di lavoro nei servizi, nei trasporti, nella ristorazione, come ha segnalato l’ISTAT e come faceva intuire anche il solo buon senso), fino a giungere al più recente (e non meno euforico) mantra sul cd. “South Working”, al quale, oltre alla bellezza di poter lavorare al Sud “vista mare e con lo stipendio di un’azienda del Nord”, si è attribuito anche un triplice potere taumaturgico: risolvere i problemi economici del Meridione, ridurre grandemente la “fuga dei cervelli” e far rinascere i più bei borghi d’Italia e nelle città le più isolate periferie. Dalla pandemia alla “Smart Italy” il passo è stato dunque brevissimo.
LA NECESSITÀ DI UN VERO CAMBIO DI PARADIGMA
Al di là di queste ultime ipotesi, collocabili tra l’utopico e il folkloristico, persistono ancora “letture” che confondono le attuali condizioni, proprie di un lavoro organizzativamente distanziato per ragioni sanitarie, con quelle di una reale, diversa ed innovativa prospettiva con la quale concepire l’attività d’impresa. È certo che l’esperienza che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo ci ha fatto compiere, nel breve volgere di qualche mese, un salto esperienziale verso l’uso e la pratica quotidiana dei sistemi digitali per compiere il quale, in condizioni normali, sarebbero occorsi alcuni anni.
È altresì certo che questa dimensione abilitante del digitale sia uno degli asset che andranno capitalizzati dalle imprese e dai lavoratori proprio ed anche per immaginare una più ampia diffusione del “vero” SW. Ed è infine senz’altro vero che, una volta superata la pandemia, la “Fase 3” schiuderà le porte ad una diversa concezione del lavoro che non potrà non tenere conto delle “scoperte” che abbiamo fatto sin qui. Tuttavia, per poter sostenere seriamente che da domani “nulla sarà come prima”, ancora ne corre. E soprattutto appare necessario un soprassalto di pensiero, di visione e di analisi, per evitare di consegnare alla tecnologia la dotazione di senso e significato da attribuire a trasformazioni destinate a modificare profondamente non soltanto la geografia economica ed imprenditoriale, ma anche gli stessi modelli antropologici del lavoro (compresi quelli della scuola e dell’università), i paradigmi culturali, le idee di città, di socialità, di esperienza vitale.
Prima del lockdown lo SW era una pratica attuata da un esiguo numero di aziende (in massima parte di grandi dimensioni) e coinvolgeva un ridottissimo numero di lavoratori subordinati: circa 570 mila, stando al monitoraggio dell’”Osservatorio Smart Working” del Politecnico di Milano. Alcune di queste aziende, pionieristicamente, avevano attuato questa nuova modalità di lavoro ben prima dell’avvento della Legge 81/2017 con la quale, in Italia, è stata data una cornice normativa allo SW.
Dalla sua introduzione il numero dei lavoratori coinvolti non è cresciuto molto, segno evidente della mancanza della premessa indefettibile per l’affermazione su larga scala del “vero” SW: la volontà (di manager e imprenditori) di avviare una profonda trasformazione del proprio mindset culturale e del complessivo paradigma organizzativo e gestionale che dall’imperativo del comando-controllo basato su strutture verticali (il cd. “ufficio-fabbrica”) possa trasformare le relazioni di lavoro e l’organizzazione complessiva dell’impresa sulla base di più forti legami fiduciari. Un passaggio che dovrebbe innanzitutto attribuire ai collaboratori maggiore autonomia e responsabilizzazione rispetto a ruoli agìti grazie a dosi crescenti di empowerment dai quali poter derivare l’ulteriore profonda modificazione di un lavoro non più svolto sulla base di mansioni standardizzate, sostanzialmente misurate sul solo parametro del tempo, ma “per fasi, cicli ed obiettivi” (Art 18, c.1, L. 81/2017) e la cui esecuzione, recita la norma testé citata, sia “eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa” e ciò che più conta “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” (fatto salvo il rispetto della “durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”).
Come si comprende si tratta di una trasformazione del lavoro che per essere realmente tale dev’essere sostenuta da una diversa impostazione tecnico-operativa complessiva che coinvolge anche gli stessi smart worker in una profonda modificazione del “vissuto” del proprio modo di lavorare.
Nella trasformazione del lavoro e dei cicli produttivi che l’evoluzione tecnologica testimonia ormai quotidianamente, occorre dunque visualizzare due modelli. Da un lato abbiamo il modello dall’esecuzione della prestazione nel pedissequo rispetto di procedure che la standardizzano, non prevedendo alcuna possibilità di apporti individuali in grado di generare valore aggiunto. Dall’altro, il modello dell’esecuzione basata sull’apporto delle expertise individuali agìto nella logica del progetto, del problem solving, dell’innovazione, del miglioramento continuo e del lavoro in team per obiettivi condivisi. Solo nello shifting dal primo al secondo modello si può realmente materializzare un mutato protagonismo della persona ed un crescente ruolo del coinvolgimento dei lavoratori (da cui anche il tema della partecipazione organizzativa, sempre più necessaria proprio in conseguenza della trasformazione del lavoro da mansioni parcellizzate a ruoli sempre più tra loro interconnessi).
Questo cambio di paradigma impone una rivisitazione radicale della cultura e dell’organizzazione aziendale che non si improvvisa, non si ottiene in tempi rapidi, né potrà dirsi avviata solo perché in azienda “si fa” SW applicando una legge che ne ha introdotta la disciplina. E soprattutto un tale cambio di paradigma non potrà essere la meccanica conseguenza di una pandemia, per quanto disruptive la si voglia considerare.
È un percorso complesso la cui attivazione presuppone che la governance, il management e l’intera struttura aziendale ne abbiano condiviso gli assunti ed intuito le potenzialità in vista di un “ritorno” in termini economici e produttivi, oltre che organizzativo-relazionali ed individuali (sul piano della dignità e della crescita professionale), tali da giustificare una trasformazione che, volendo fare un paragone chimico, equivale ad un “passaggio di stato”: da quello “solido” (staticità, con rigida impostazione verticale ed orientamento al solo profitto per gli shareholders) a quello “liquido” (valorizzazione delle capability, dinamiche di partecipazione diretta dei lavoratori, apertura agli interessi di tutti gli stakeholder e spinta alla creazione di shared value a partire dal team di lavoro). Quest’ultima notazione ci dice molto dell’ampiezza della trasformazione che, per essere anche innovazione, deve estendersi lungo l’intera filiera delle relazioni dell’impresa (all’interno e all’esterno di essa).
Gli effetti sociali del “lavoro remotizzato” sono sotto gli occhi di tutti: è evidente che la diffusione di questa prassi non chiama in causa solo il giuslavorismo e la tecnica manageriale, ma mette in gioco anche riflessioni su altri aspetti non meno rilevanti e non meno importanti anche per le stesse aziende. Basti pensare ai trasporti, alla socialità, alla ridefinizione dell’offerta dei servizi delle città e più in generale alla nuova coerenza che dovranno trovare le diverse infrastrutturazioni che riguardano la vita ed il lavoro. Un vaste programme riformista per il quale non sarà sufficiente mettere in campo pur nobili sentimenti e visionarie utopie, ma che dovrà mobilitare nel tempo azioni di ridisegno complessivo delle politiche territoriali, grazie al contributo di progettisti, urbanisti, esperti dei trasporti, sociologi urbani ed economici, esperti di economia dei servizi, e così via.
IL RISCHIO DELLA “GIURIDIFICAZIONE”
L’attuale spinta verso una riscrittura della legge 81/2017 con l’intento di voler normare ogni più singolo aspetto del “lavoro agile” (con l’ipotesi, ventilata dal Ministero del Lavoro, della definizione di prefissate “quote” massime di lavoratori “smartabili”) è la meno “agile” delle soluzioni perché finirebbe per stravolgerne lo spirito e la natura: è la “giuridificazione” il nemico dello SW.
Il “lavoro agile” è una scelta organizzativa che deve essere liberamente assunta dalle imprese laddove ve ne siano le condizioni culturali, tecnologiche ed organizzative: tutte cose che nessuna legge può introdurre e che pertanto non possono che restare nella libera determinazione di ciascuna azienda secondo le proprie e non meno libere scelte strategiche.
Del tutto diversa è la questione della contrattazione collettiva che la legge 81/2017 non prevede, affidando l’attivazione dello SW alla stipulazione di singoli accordi individuali. In disparte l’evidenza che lo SW è comunque spesso già regolato (anche) da accordi di natura collettiva aziendale (quali presupposti di quelli individuali), non può sottacersi che lo SW riguarderà sempre di più non singole persone o qualche élite aziendale, ma gruppi sempre più numerosi di lavoratori ed avrà quindi un forte impatto collettivo per il che sembra improbabile poterne escludere una regolazione che non abbia una tale corrispondente natura. Il riferimento va non già alla contrattazione nazionale che finirebbe inevitabilmente per limitare l’agilità delle nuove modalità di lavoro, ma a quella aziendale e territoriale che, invece, ha la capacità di cogliere le singole necessità delle imprese e quelle delle diverse “popolazioni” che le abitano (età, grado di istruzione, genere e composizione dei nuclei familiari sono solo alcuni degli aspetti socio-demografici che devono potersi armonizzare nell’ambito di un progetto di trasformazione come quello associabile all’introduzione stabile dello SW).
Analogo rischio connesso alla “giuridificazione” dello SW è quello che si materializza tramite la definizione di nuovi “diritti”. L’attuale disciplina emergenziale applicata al “lavoro agile” se, da un lato, ha sospeso i presupposti giuridici ordinari dello SW, dall’altro l’ha confuso con il “lavoro da remoto forzato” necessario a realizzare il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, così disegnando (temporaneamente) uno strumento che, nel consentire la prosecuzione delle attività aziendali, è stato sostanzialmente votato anche alla conciliazione vita-lavoro, soprattutto tenendo conto di alcuni “carichi” familiari e/o di talune condizioni individuali. È ciò che i decreti del Governo hanno fatto attraverso una serie di previsioni che hanno attribuito un “diritto allo smart working” a coloro il cui profilo personale o il cui nucleo familiare presenti specifiche criticità alle quali il “lavoro da casa” può dare sollievo (è il caso di alcune pregresse patologie individuali, dell’assistenza ai disabili e della cura dei figli minori di 14 anni, ivi incluso il caso di un loro contagio “scolastico” da Covid-19).
In una situazione emergenziale questo approccio è ovviamente condivisibile, tanto più che non si riferisce al reale “lavoro agile”. Più critica diventerebbe la questione, invece, ove domani si dovessero delineare stabili “diritti” allo SW e ciò perché ad una prassi socio-tecnica – associata ad una trasformazione culturale ed organizzativa (quindi un tema squisitamente manageriale) – diventerebbe difficile immaginare di potervi associare anche la valenza propria di un istituto del diritto del lavoro sul quale basare la sussistenza di pretese soggettive alla sua concessione (benché ciò sia già avvenuto con la legge di bilancio del 2019 che ha introdotto un diritto di priorità nell’accoglimento delle richieste di accesso al lavoro agile delle lavoratrici nei tre anni successivi al congedo di maternità e per i genitori di figli disabili).
Anche tralasciando di considerare il fatto che da una tale impostazione deriverebbero conseguenze del tutto contrarie a quel rinnovato rapporto fiduciario che lega l’impresa allo smart worker (ogni eventuale diniego all’esercizio di quel diritto avvierebbe un contenzioso che finirebbe per sostituire il giudice del lavoro all’imprenditore), è evidente che un’impostazione di questo tipo ne cambierebbe radicalmente la natura e ciò sulla premessa che le sedi per l’introduzione di una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che debba tenere conto delle esigenze di (o financo di diritti alla) conciliazione vita-lavoro saranno quelle usuali (legge, contratto collettivo o regolamento aziendale). L’attivazione di tali ultime modalità prescinderà dal tipo di organizzazione che l’azienda s’è data, come del pari prescinderà dal tipo di cultura del lavoro presente in una data impresa (al più quest’ultima potrà condurre, se rispettosa delle necessità anche extra-lavorative dei suoi dipendenti, a modificare in melius quanto già previsto dalle fonti poc’anzi citate, magari rafforzando anche le prassi di welfare aziendali già presenti).
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA
La “grande trasformazione” che la digitalizzazione del lavoro e dei cicli produttivi (di beni e di servizi) porta con sé, nel quadro della diffusione della cd. “Impresa 4.0”, non riguarda solo l’adozione di specifiche tecnologie abilitanti e il superamento del paradigma produttivo fordista, ma si estende oltre i confini della produzione essendo capace di impattare sulle dinamiche della vita delle persone e del lavoro, sul suo senso e sulle relazioni (umane ed industriali).
Un outcome dello SW è quello di facilitare quella “fioritura” dell’umano della quale il lavoro del futuro sempre più necessita e senza la quale l’innovazione che dovrà sostenerlo non potrà dirsi pienamente raggiunta. Il che ci dice che le utopie che hanno visto nello sviluppo tecnologico “la fine del lavoro” o addirittura la “liberazione dal lavoro” o quelle tecnofobiche, pronte ad immaginare una sempre più diffusa ed inarrestabile disoccupazione tecnologica e per gli occupati la dipendenza dalle decisioni autonomamente assumibili dalle macchine (con un’inversione di rapporto tra umanità e tecnologia), sono appunto utopie (sulla loro falsariga s’innestano anche quelle più recenti sulla presunta imminente “morte dell’ufficio”, sostenute da una visione distorta del senso e del significato più profondo dell’innovazione organizzativa sottesa alla diffusione del “vero” SW).
Tanto più che, al contrario, se nel quadro della cd. “Quarta Rivoluzione Industriale” c’è un elemento che riconquista un ruolo centrale nella produzione di beni e servizi, questo è proprio il lavoratore considerato come Persona, ossia nella sua integralità umana, il cui apporto diviene essenziale rispetto alla possibilità di immaginare luoghi di lavoro nei quali la collaborazione e la cooperazione assumano, a loro volta, centralità e significato. È qui che, ad esempio, s’innestano con maggiore profondità anche quei meccanismi di partecipazione diretta dei lavoratori alla co-progettazione dell’organizzazione del lavoro che ridefiniscono il rapporto gerarchico introducendo contesti nei quali, su un piano di pari dignità (in termini anche di voice) addetti alla produzione e management discutono e condividono idee ed obiettivi nel quadro di una rinnovata visione della stessa idea di azienda (l’impresa “bene comune”, l’impresa “cooperativa” e l’impresa come “comunità di destino” che la crisi scatenata dalla pandemia ha fatto emergere in tanta parte del nostro tessuto produttivo).
Ovviamente queste “spinte” sono esposte al rischio di resistenze da parte di manager che, pur sempre pronti a sostenere la necessità di poter contare su collaboratori maggiormente responsabilizzati, dotati di soft skill che ne rafforzino l’autonomia e la capacità di operare in base a logiche di problem solving, sono spesso, in realtà, ancora appesantiti da una mentalità formatasi nel secolo scorso, incentrata sul solo controllo e non sulla visione di un’impresa più reticolare, fondata su ruoli interscambiabili, in buona parte auto-diretti e fiduciariamente agìti nella pienezza delle possibilità di espressione delle capability di ciascuno. Sono questi presupposti che reclamano idonei “spazi di manovra” affinché nelle nuove organizzazioni il lavoratore sia considerato per il complessivo insieme delle sue potenzialità da esprimere attraverso l’apporto di valore che deriva dalla sua azione. È in questo orizzonte che si collocano relazioni basate sulla forte condivisione di obiettivi ed è in questi contesti che diventa possibile riconoscere centralità alle competenze e ai risultati prodotti, con quel che ne deriva sul piano di altri “spazi di manovra”, come quelli della ridefinizione delle politiche di compensation, in particolare in relazione alle componenti variabili della retribuzione collegate al raggiungimento dei target. Sembra coerente attendersi che al crescere dell’autonomia del lavoratore “agile”, espressa in una nuova dimensione spazio-temporale del lavoro, cresca il peso della variabilità della retribuzione agganciata ai risultati.
Si delinea, così, una subordinazione diversa da quella cui siamo abituati a pensare: quest’ultima – unicamente incentrata sullo scambio salario/prestazione – non è sempre pienamente capace d’innescare dinamiche di reciprocità che, invece, nei contesti che stiamo descrivendo, diventano possibili ed anzi necessarie ed al cui rafforzamento sono dedicate anche le policy di welfare aziendale in “combinato disposto” con l’adozione di nuove modalità di lavoro delle quali lo SW è una delle concrete manifestazioni.
Il “lavoro agile”, inteso ed interpretato come prassi socio-tecnica, è destinato a sostenere una trasformazione del lavoro che chiama in causa la persona del lavoratore nella totalità delle sue manifestazioni e per la liberazione delle quali la responsabilizzazione, il coinvolgimento, il re-design dei ruoli e dei processi – inteso come la possibilità di lavorare sulla base di una visione progettuale della propria azione – rappresentano i presupposti anche per il consolidamento di quel modello di “Impresa 4.0” che si sta progressivamente realizzando. Da questo angolo visuale, senza omettere di considerare anche gli effetti negativi che qualunque trasformazione tecnologica porta con sé sul piano occupazionale, può essere interessante notare come, al crescere della complessità e della capacità della tecnologia, la persona conti di più e diventi sempre meno fungibile soprattutto se ciascuno avrà avuto la possibilità di “fiorire” sul piano delle conoscenze, delle competenze e della propria realizzazione professionale ed umana.
Non è un caso che, proprio sulla base di queste evidenze, le più avvedute teorie di management e le stesse relazioni industriali contemporanee facciano ormai espresso riferimento ad un “Nuovo Umanesimo” con il quale permeare il lavoro e l’organizzazione d’impresa. Ed è proprio di un nuovo umanesimo che si sente il bisogno, dentro e fuori dai luoghi di lavoro ed ovunque essi siano collocati.
Giovanni Scansani, co-founder Valore Welfare Srl e docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano
Luca Pesenti, professore associato nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



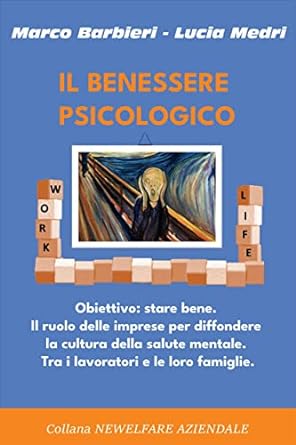













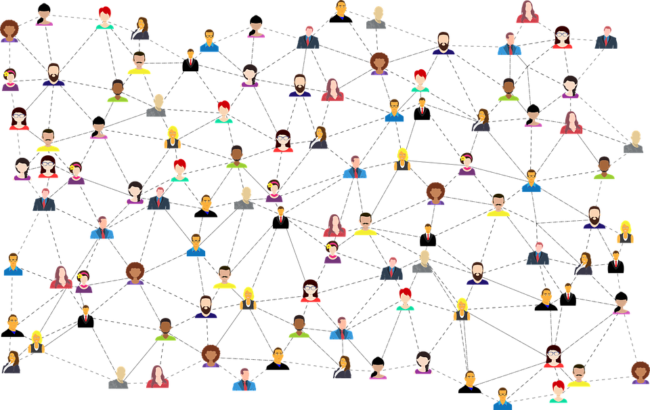


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025