Il welfare aziendale dopo il Covid-19: iniziamo dallo smart working. Oggi il primo dei sei appuntamenti proposti da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano e da Giovanni Scansani, co-fondatore di Valore Welfare (gruppo Cirfood), advisor specializzato nella materia.
Sono più o meno cinque anni che lo smart working è entrato di prepotenza nel dibattito pubblico e nel linguaggio corrente del nostro Paese. Già attuato da alcuni grandi aziende anche prima che fosse normato in modo organico, per la prima volta, con il Jobs Act (2015), successivamente è stato oggetto di un estenuante iter parlamentare, per giungere finalmente ad una codificazione definitiva con la Legge n. 81/2017. Partiamo allora da qui per capire di che cosa stiamo esattamente parlando. Perché l’impressione è che ci sia qualcosa di stonato nel modo con cui lo si sta raccontando (soprattutto dall’inizio dell’emergenza) in questo periodo di riassestamento da remoto di (quasi) tutti i lavori possibili.
Con smart working possiamo sinteticamente definire una specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa caratterizzata dalla possibilità di lavorare dove, quando e come si vuole. Contiene dunque il riconoscimento, da parte dell’azienda, di una forte dose di libertà nell’adempimento della prestazione di lavoro (ciò che la contraddistingue nettamente dal telelavoro).
Operativamente rappresenta una modalità di esecuzione dell’ordinaria prestazione lavorativa contrattualmente definita con ciascun “lavoratore agile” ed associata ad una un’evoluzione del telelavoro; essa è basata sull’uso e la piena disponibilità di strumenti informatici e telematici che consentono lo svolgimento del lavoro anche mutando il luogo in cui la prestazione è erogata (ad esempio da casa o da un coworking).
Nella sua essenza (e dalle sue corrette prassi esecutive) lo smart working è inteso come una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati (utilizziamo qui la definizione che ne dà l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano).
Per potersi dire davvero smart, il lavoro deve possedere quattro requisiti fondamentali: i) una specifica cultura organizzativa non più unicamente basata sulla presenza fisica e sul controllo visivo, ma sulla responsabilizzazione verso i risultati, ii) l’esplicita introduzione di politiche aziendali orientate alla flessibilizzazione degli orari e dei luoghi di lavoro, iii) adeguate dotazioni tecnologiche (garantite dall’azienda ai lavoratori coinvolti, e iv) adeguati spazi fisici.
Proprio alla luce di questa definizione generale, l’esaltazione che in queste settimane è stata fatta dello smart working (che di smart adesso ha ben poco perché, per la maggior parte delle persone coinvolte, è solo lavoro da remoto coatto) è apparsa impropria e persino controproducente anche rispetto ad una corretta lettura di questo istituto. Basterebbe anche solo pensare al fatto che la fonte istitutiva dell’attuale sedicente smart working non è più l’accordo con il singolo lavoratore, ma l’automaticità derivante dall’unilaterale decisione datoriale ora consentita dalla disciplina emergenziale dei dpcm susseguitisi sin qui. Lo smart working al tempo del Covid-19, pertanto, non c’entra nulla con questa pratica, almeno quando essa sia riferita ad aziende (la maggior parte) che, se non ci fosse stata la pandemia, a questa modalità di lavoro non sarebbero certo arrivate (o, almeno, non con questa velocità).
La sensazione è che molti di coloro che sono stati “messi” in smart working, soprattutto se non precedentemente avvezzi a questa condizione (ancora una volta: la stragrande maggioranza, se è vero che sempre l’Osservatorio del Politecnico ha stimato in soli 570mila il numero di “lavoratori agili” nel nostro Paese), non vedono l’ora di tornare al loro posto di lavoro. E i motivi sono molti. Perché, per i più, la casa non è propriamente il luogo ideale per lavorare. Immaginatevi ad esempio una coppia impegnata in qualche call e in “incontri” via web con i colleghi di lavoro, contemporaneamente chiamata a seguire uno o più figli piccoli durante le lezioni in home schooling. Figli – sia detto per inciso – che a loro volta (che come “lavoro” fanno gli alunni nelle scuole), non vedono l’ora di tornare in aula. O ancora, immaginiamoci le condizioni di lavoro di coloro i quali non possono vantare la presenza in casa di uno spazio specifico dedicato (uno studio, per esempio). Ma anche le difficoltà di chi deve fare i conti con dotazioni tecnologiche e/o reti internet non adeguate perché un po’ vecchiotte e/o lente. Sommiamo tutti questi elementi e possiamo immaginarci una nuova geografia delle diseguaglianze (sociali ed economiche) al tempo del Covid 19.
Ma oltre a questi elementi strutturali, c’è anche altro. Qualcosa che occorrerà mandare a memoria, per sapere resistere a tentazioni utopistiche sul lavoro che verrà. La temporanea assenza da uffici, fabbriche, studi, scuole, università, officine, insomma dai luoghi in cui ogni giorno milioni di persone si recano per lavorare, ci sta dando un’utile lezione culturale, forse addirittura antropologica. Ci mancano i colleghi dell’ufficio, come ai figli mancano i compagni di banco o di corso. Certo ci sono internet e la tecnologia a darci una mano, ma non è facile stare da soli, per settimane, davanti ad uno schermo e continuare a sentirsi parte di un team come quando le relazioni con gli altri si vivevano offline, come quando c’era la fisicità dei luoghi, dei suoni o dei rumori e quella delle parole e degli occhi di chi ci stava di fronte.
Lavorare da casa, nelle attuali condizioni, non è la stessa cosa e ciò non foss’altro perché non è stata una nostra scelta, ma un’inevitabile costrizione e per di più la peggiore: quella causata dalla paura.
Abbiamo scoperto, stando a casa lavorando (invece che solo per godere dei nostri affetti e del nostro tempo libero), che prima di amare gli spazi di fondamentale libertà dal lavoro, amiamo proprio il lavoro e lo amiamo nel luogo dove il lavoro si fa normalmente: negli uffici, nelle fabbriche, nelle scuole, in ogni luogo dove si stia a contatto con gli altri e per gli altri.
Lavorare è stare immersi nell’ambiente che il lavoro genera e riproduce: è questo il “bene comune” che adesso ci manca e che ci è stato rapinato dal “male comune” del virus che ci ammorba.
Basta questo a far capire che lo smart working ai tempi del Covid-19 non è affatto lavoro agile, perché la sua premessa, e soprattutto la sua promessa, sta proprio nella libertà di sceglierselo e di organizzarselo. È solo così che il work diventa smart e diventa anche una misura di benessere organizzativo dentro e fuori dal luogo di lavoro (e quindi di Welfare Aziendale).
Tutto ciò, senza ovviamente tacere il fatto che lo smart working (quello vero) non è “lavoro da casa”, ma è il risultato di un ben più complesso processo di change management che ruota intorno ad un cambio di prospettiva epocale nelle aziende: dal controllo “qui e ora” alla valutazione dei soli risultati generati da un contesto massimamente fiduciario al quale, però, molti manager fino in fondo ancora non credono, convinti come sono che la formula “presenza fisica + controllo visivo” esaurisca il potere direttivo (un evidente misunderstanding tra autorità e autorevolezza). Non a caso (e chiudiamo tornando a citare i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano) quei 570mila smart worker italiani distribuiti nel 58% delle grandi imprese mostrano più elevati livelli di soddisfazione, un più diffuso engagement e un miglior rapporto con i “capi” cui debbono rispondere.
Quanta soddisfazione troveremmo oggi, domandandolo ai milioni di lavoratori costretti a lavorare in casa per tentare di lasciar fuori la paura? Sinceramente crediamo poca, ma lasciamo una più corretta risposta all’esito della specifica ricerca che in questi giorni, proprio su questo tema, sta svolgendo l’Università Cattolica di Milano e della quale vi daremo conto prossimamente (coloro che desiderassero partecipare potranno farlo rispondendo al questionario che si trova a questo link.
Luca Pesenti
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani
co-fondatore di Valore Welfare (gruppo Cirfood), advisor di welfare aziendale
1 – continua
———————



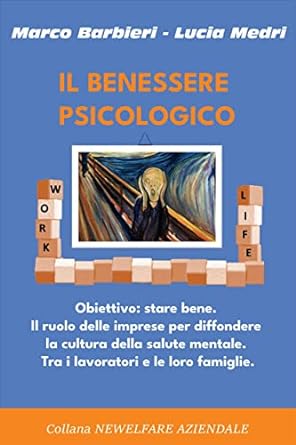













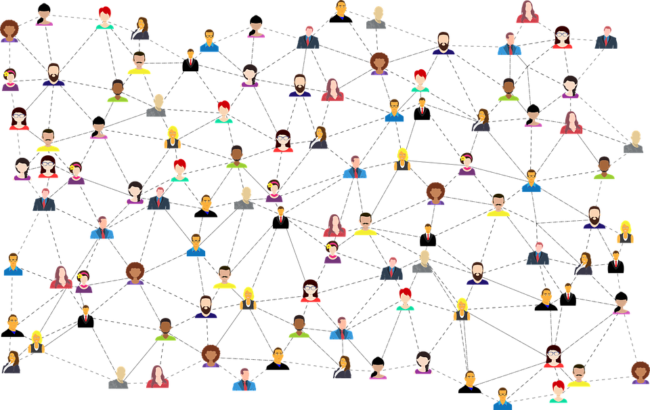


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025