Terza puntata della riflessione (in otto puntate) del nuovo approfondimento dedicato allo smart working da Giovanni Scansani, consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, e da Luca Pesenti, docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Con l’arrivo della pandemia tutto l’impegno svolto dai più seri promotori del “lavoro agile” sembra abbia perso un po’ di grip sia nei confronti delle imprese (disturbate dalle fantasie “libertarie” di una narrazione dello SW sostenuta da un dibattito fattosi spesso a-tecnico), sia (e soprattutto) nei riguardi della politica che sulla scorta delle norme emergenziali non ha avuto difficoltà ad impossessarsi del “giocattolo” arrivando ad ipotizzarne anche una futura nuova disciplina, benché sulla base di assunti che, in buona parte, sembrano negare la natura stessa dello SW propriamente inteso.
Lavori e lavoratori “smartabili”
Uno degli assunti più contraddittori era quello originariamente insito nella proposta volta alla fissazione di “quote” di lavoratori che le aziende e le pubbliche amministrazioni avrebbero potuto collocare in “lavoro da remoto” (usiamo questa espressione perché ciò che ne deriverebbe non potrebbe certamente chiamarsi “lavoro agile”). L’ipotesi, risalente ad alcuni mesi or sono, fu subito molto criticata, ma è stata poi proprio questa l’impostazione prescelta per il settore pubblico: nella fase emergenziale la “quota” ritenuta congrua è quella, molto salomonica, del 50% della pianta organica riferibile ai lavori cd. “smartabili” (neologismo il cui copyright appartiene a Fabiana Dadone, Ministro della Funzione Pubblica).
Sono note le polemiche che sono seguite a questa decisione. Un giuslavorista del calibro di Pietro Ichino non aveva mancato di sottolineare come, nella quasi totale assenza dei presupposti culturali ed operativi – anche solo per praticare un lavoro “da remoto” – la condizione nella quale si sono trovati molti dei dipendenti pubblici sia stata quella “di una lunga vacanza pressoché totale retribuita al cento per cento” (Corriere della Sera, 15.6.2020)
Sulla stessa lunghezza d’onda s’era posto un altro insigne giurista come Sabino Cassese che, sottolineando come “i livelli di produttività [fossero] già bassi prima” (anche perché “la pubblica amministrazione italiana ha una organizzazione pre-tayloristica”, tant’è che “persino il basilare tempi e metodi che è all’origine della società industriale del Novecento non è mai stato assorbito”), aveva anch’egli evidenziato come lo SW emergenziale “per molti [sia] stato e [sia] tuttora un grande periodo di vacanza” (IlSole24Ore, 5.7.2020). Chiudendo la querelle, egli è poi tornato sul tema con un calzante richiamo alla fantascienza riportato sin dal titolo dell’articolo che conteneva una sua intervista: “Chi dice che l’amministrazione funziona come prima vive su Urano” (Sole24Ore, 16.10.2020).
Nonostante ciò, con il recente decreto ministeriale del 9 dicembre 2020 l’impostazione è stata confermata incrementando la quota ad “almeno il 60%” dei lavoratori che svolgono mansioni “smartabili” (non è noto perché proprio quella e non un’altra percentuale). Con il medesimo decreto sono state approvate anche le “Linee Guida” per la redazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA). Tali “Linee Guida” sono la plastica manifestazione della tipica, italianissima, predisposizione per la “burocratizzazione” dei fenomeni sociali (tali ovviamente sono anche quelli che riguardano il lavoro), a sua volta figlia di una rischiosa spinta alla “giuridificazione” che, una volta applicata allo SW, finisce per modificarne la natura trasformandolo da strumento dell’innovazione a meccanismo di un diritto del lavoro lontano dalle trasformazioni organizzative e culturali in atto.
La “giuridificazione” dello Smart Working
In cosa si sostanzi la “giuridificazione” l’ha ben illustrato Pietro Ichino che, peraltro, ne aveva evidenziato i rischi sin dai tempi della discussione che condusse all’approvazione della legge sullo SW (L. 81/2017). In gioco c’era (e c’è) il rischio che il “lavoro agile” perda proprio la sua “agilità” ove questa dovesse essere “fagocitata dal business della burocrazia giuslavoristica incominciando così ad essere appesantita da regole, verbalizzazioni, scartoffie e ricorsi” (in questo si sostanzia quella che per Ichino è “Un’idea sbagliata dello smart working” – lavoce.info, 6.7.20).
Rischi, per fare un esempio, dei quali il desaparecido “Piano Colao” non sembrò, invece, preoccuparsi più di tanto, attesa che aveva suggerito di definire una disciplina legislativa dello SW particolarmente analitica e dettagliata, riferibile a “tutti i settori, le attività e i ruoli (manageriali e apicali inclusi), con particolare attenzione alla pari fruibilità per uomini e donne”. Problema non secondario, quest’ultimo: lo SW emergenziale, per molte donne, “si è trasformato in extreme working” come aveva evidenziato un sondaggio di “Valore D” svoltosi durante il lockdown e ciò, oltretutto, in un contesto generale nel quale la domanda di conciliazione tra vita e lavoro complica il quadro da sempre. Lo SW, infatti, sembra avere un effetto limitato sulla riduzione del conflitto lavoro-famiglia, mentre può aumentare quello tra famiglia e lavoro (si parla, in tal caso, di work-life imbalance).
Ma a quale punto possa arrivare la “burocratizzazione” ce lo rappresenta l’INAIL nella sua “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art 22, comma 1, L. 81/2017”, come si può capire leggendone qualche passaggio.
Ad esempio, qualora si lavori in esterno – magari ai giardinetti – sarebbe bene precisare di “non frequentare aree con presenza di animali incustoditi” e di “evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso” ragion per cui meglio “dotarsi di creme contro le punture, antistaminici e abbigliamento adeguato” (sembra un’uscita di trekking…). Si consiglia poi di “non frequentare aree con presenza di rifiuti” e di “evitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari”. Qualora, invece, si lavori al chiuso l’avvertimento è di non stare nei box o nelle cantine o nelle soffitte e di ricordarsi sempre di “collocare le lampade in modo da evitare la proiezione di ombre che ostacolino il campo visivo” oltre che – ed era opportuno ricordarlo – di “non lavorare mai al buio”.
Contro i rischi della “giuridificazione” e della burocratizzazione e soprattutto contro l’ipotesi di riforma della L. 81/2017 o della stesura ex novo di una diversa (e più analitica) disciplina si sono pronunciati negativamente (e giustamente) in molti.
In particolare, nel mese di settembre dell’anno scorso, un gruppo di giuristi, consulenti e sindacalisti ha inviato un “Appello al Governo” per dire “no alla iper regolazione” (ossia: no a una nuova legge o alla riforma di quella esistente) e sì alla concessione di “più spazio alla contrattazione”. L’inopportunità di una nuova disciplina sul “lavoro agile” non solo può rinvenirsi nel rischio di “giuridificazione” di cui s’è appena detto, ma è testimoniata anche dal fatto che, già rispetto all’attuale legge in vigore, l’intervento del legislatore è sopravvenuto ad un quadro regolativo che, ben prima, era già stato definito dall’autonomia collettiva e ciò proprio in quanto per avviare percorsi di “lavoro agile” una legge, a stretto rigor di logica, non era neppure necessaria (alcune grandi aziende il “lavoro agile” l’avevano introdotto ben prima della pubblicazione della L. 81/2017).
Il “diritto allo Smart Working”
Rientra in questa italica propensione a normare anche ciò che può (deve) essere lasciato all’autonomia degli attori sociali anche la previsione emergenziale di un set di “diritti allo smart working” che snatura l’essenza del “lavoro agile”.
La soddisfazione delle necessità di conciliazione vita-lavoro, insita nell’accoglimento delle richieste volte alla fruizione della possibilità di poter eseguire le proprie mansioni tenendo conto delle condizioni fisiche personali e/o delle criticità dei carichi di cura familiari, attiene alla regolazione del rapporto di lavoro già fatta propria da specifiche norme come, ad esempio, la Legge 104/1992 (che semmai l’emergenza poteva indurre a novellare anche solo pro tempore). Non solo: spesso di questi temi se ne occupa proprio la contrattazione e tra l’altro anche in senso più ampio rispetto al diritto positivo vigente.
Questi temi, quindi, sono (e dovrebbero continuare ad essere) disciplinati da norme ad hoc senza attribuire una diretta funzione “sociale” allo SW che è (e deve restare) una modalità organizzativa del lavoro caratterizzata da una sua coerente armonizzazione con i nuovi paradigmi manageriali propri di quei contesti d’impresa che abbiano previamente realizzato quelle innovazioni organizzative che, proprio in quanto espressione dell’attività imprenditoriale, sono e devono restare libere, senza essere sottoposte alla “spada di Damocle” di possibili impugnazioni giudiziali.
Un “diritto al lavoro agile” che si consolidasse come tale anche oltre la disciplina emergenziale comporterebbe – ci avverte ancora Pietro Ichino a proposito della ricordata “idea sbagliata dello smart working” – “l’onere permanente per il management aziendale di verbalizzare i motivi del rifiuto opposto alla richiesta di qualsiasi dipendente […] anche di chi è incaricato di mansioni che non possono svolgersi in alcun modo da remoto […]” ma che “potrebbe rivendicare lo spostamento a mansioni compatibili. E i motivi dell’eventuale rifiuto diventerebbero a quel punto un possibile oggetto d’impugnazione e quindi di verifica in sede giudiziale, col risultato di sostituire il giudice del lavoro all’imprenditore in questo aspetto della gestione aziendale”.
Va da sé che uno SW promosso in tal modo non avrebbe più molto di smart perché “nascerebbe con un imprinting contenzioso, quindi senza alcun rapporto di fiducia tra le parti” (che invece è un presupposto cardine del “lavoro agile”).
La delicatezza delle questioni sottese ai “diritti allo smart working” riguardano aspetti della disciplina del rapporto di lavoro che devono necessariamente poter prescindere dall’assetto organizzativo che un’impresa si sia dato (devono, cioè, prescindere dall’avere o meno adottato policy di “lavoro agile”). L’avversione all’introduzione di simili diritti, del resto, era già emersa quando, prima della pandemia, non era stato salutato con favore neppure quel “diritto di precedenza” che la Legge di Bilancio per il 2019 ha attribuito alle lavoratrici nei tre anni successivi alla maternità e ai genitori caregiver di figli disabili.
Analoghe conclusioni valgono anche per l’ipotesi di una nuova legge sul “lavoro agile”: questa è da taluni auspicata – anche sulla scia di iniziative assunte in altri Paesi europei come la Germania – con l’auspicio che, per suo tramite, possa essere introdotto un generale “diritto allo smart working”. Queste proposte, però, non sembrano andare nella corretta direzione, ossia quella di conservare i più ampi spazi di manovra al dispiegamento della “grande trasformazione” del lavoro e dell’organizzazione d’impresa i cui limiti – rispetto ai diritti e ai doveri dei lavoratori e degli imprenditori – appaiono già fissati dal diritto. È, invece, alla contrattazione tra le parti che va affidata la concreta definizione del “lavoro agile” nella fisionomia più confacente ai diversi contesti d’impresa nei quali dovrà trovare il suo armonico inserimento. Sarà questo l’argomento del quale parleremo nella prossima puntata.
Luca Pesenti,
docente di Sistemi di Welfare Comparato e di Organizzazione e Capitale Umano all’Università Cattolica di Milano
Giovanni Scansani,
consulente aziendale, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare
(Continua)



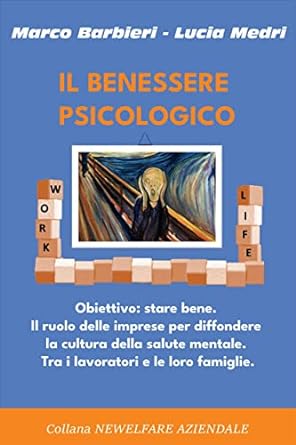













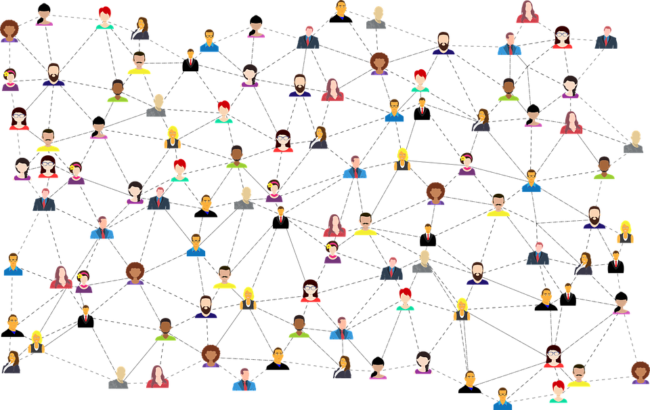


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025