COVIP: pubblicata la relazione 2023 sui fondi pensione
A fine 2023, il totale degli iscritti alla previdenza complementare è di 9,6 milioni, in crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente; in percentuale delle forze di lavoro, gli iscritti sono pari al 36,9%. I fondi negoziali contano 3,9 milioni di iscritti (+5,4% rispetto al 2022). La metà delle nuove adesioni è da ricondurre al meccanismo dell’adesione contrattuale; continuano a crescere anche le iscrizioni nel settore del pubblico impiego attraverso il meccanismo del silenzio-assenso per i lavoratori di nuova assunzione. Alla fine del 2023, sono in essere 302 forme pensionistiche: 33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (PIP) e 161 fondi preesistenti.
Resta il gap generazionale: solo il 19,3% degli iscritti è under 35. Lo stesso dicasi per il gap di genere: solo il 38,3% sono donne. Sono alcuni dei dati diffusi ieri da Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nella relazione relativa al 2023.
La presidente, Francesca Balzani, a proposito del gap generazionale ha precisato: “All’interno della componente più giovane, mostra segni di interessante dinamismo quella con meno di 20 anni di età, salita dal 2,2 per cento del 2019 al 2,6 del 2023. Sono per lo più soggetti fiscalmente a carico di individui che lavorano, la cui iscrizione viene indirizzata per lo più a favore di forme di mercato. Ciò rispecchia decisioni familiari di aprire una posizione previdenziale per i propri figli in vista di una successiva alimentazione con versamenti autonomi una volta che essi entreranno nel mondo del lavoro”.
Il diverso coinvolgimento nel mercato del lavoro contribuisce a spiegare in larga parte le differenze nella partecipazione alla previdenza complementare in un’ottica di genere e per classi di età. Rispetto alle forze di lavoro la partecipazione alla previdenza complementare cresce all’aumentare dell’età: tra i 15 e i 34 anni si attesta al 27,4%, per salire al 32,8% nella fascia compresa tra 35 e 44 anni, al 36% nella classe 45-54 e infine al 45% tra 55 e 64 anni. Rispetto a cinque anni prima, il tasso di partecipazione della classe più giovane cresce di 6 punti percentuali e quello delle altre fasce di 3,5-4 punti percentuali. Rispetto all’occupazione, il 37,6% dei lavoratori dipendenti aderisce a forme complementari contro il 23,5% dei lavoratori autonomi; la forbice si allarga considerando i soli iscritti per i quali risultano effettuati versamenti, molto meno presenti tra gli autonomi.
IL PATRIMONIO E GLI INVESTIMENTI
Alla fine del 2023, le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari si attestano a 224,4 miliardi di euro, con un incremento del 9,1% rispetto all’anno precedente, determinato prevalentemente dalla dinamica positiva dei mercati finanziari. Le risorse accumulate sono pari al 10,8% del PIL e al 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane. I fondi negoziali detengono il 30,2% del totale delle risorse, i fondi aperti il 14,5% e i PIP il 25,3%; il peso dei fondi preesistenti, pari al rimanente 30% del totale, per la prima volta quest’anno non risulta prevalente rispetto a quello dei fondi negoziali. I contributi incassati nell’anno sono pari a 19,2 miliardi di euro (+5,2% rispetto al 2022), in crescita in tutte le forme pensionistiche complementari: nei fondi negoziali sono stati raccolti 6,5 miliardi di euro (+7,7%); nei fondi aperti 3,1 miliardi (+7,4%), nei PIP “nuovi” 5,1 miliardi di euro (+2,3%); nei fondi preesistenti sono confluiti 4,3 miliardi di euro (+3,8%).
A ciò si aggiungono i 114,3 miliardi del patrimonio delle Casse di previdenza (+10,11% rispetto alla scorso anno).
Gli investimenti dei fondi pensione (escluse le riserve matematiche presso imprese di assicurazione e i fondi pensione interni a enti e società) sono prevalentemente allocati, per il 56% del totale, in obbligazioni governative (il 14,1% sono titoli del debito pubblico italiano) e altri titoli di debito.
Nell’insieme, il valore degli investimenti dei fondi pensione nell’economia italiana (titoli di Stato, titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili) è di 36,6 miliardi di euro, pari al 19,4% del totale a fronte del 20,8% del 2022 (35,5 miliardi di euro). Gli impieghi in titoli di imprese domestiche rimangono stabili rispetto all’anno precedente (2,4% delle attività). Il totale degli investimenti è di 4,6 miliardi di euro, così ripartito: 2,8 miliardi in obbligazioni e 1,8 miliardi in azioni; gli investimenti domestici detenuti attraverso quote di OICVM si attestano a 1,7 miliardi di euro.
I RENDIMENTI: BENE L’AZIONARIO
Nel 2023 la dinamica positiva dei mercati finanziari si è riflessa sui rendimenti di tutte le tipologie di linee di investimento, recuperando le perdite subìte nell’anno precedente. I risultati migliori si sono osservati nelle linee d’investimento con una maggiore esposizione verso i titoli di capitale. I comparti azionari hanno registrato le performance migliori, con rendimenti nell’anno in media pari al 10,2% nei fondi negoziali, all’11,3% nei fondi aperti e all’11,5% nei PIP; nei comparti bilanciati i guadagni sono stati inferiori. Anche i comparti obbligazionari hanno registrato nell’anno rendimenti positivi: gli obbligazionari misti hanno ottenuto il 7,2% nei fondi negoziali e il 4,4% nei fondi aperti; risultati positivi, ma inferiori, si sono registrati in media anche nei comparti obbligazionari puri e in quelli garantiti.
Una corretta valutazione della redditività del risparmio previdenziale non può tuttavia limitarsi ai rendimenti di un solo anno, ma deve fare riferimento a orizzonti più lunghi e coerenti con i vincoli temporali che a esso si applicano in ragione degli obiettivi perseguiti. Su un periodo di osservazione decennale (da fine 2013 a fine 2023), i rendimenti medi annui composti delle linee a maggiore contenuto azionario si collocano, per tutte le tipologie di forme pensionistiche, tra il 4,2 e il 4,5%, superiori al rendimento medio delle linee obbligazionarie e anche al tasso di rivalutazione del TFR (pari al 2,4% nel decennio). Le linee bilanciate mostrano rendimenti medi che vanno dall’1,9% dei PIP di tipo unit linked al 2,7% dei fondi negoziali e al 2,9% dei fondi aperti.
Alle differenze di rendimento tra le forme contribuiscono, oltre all’asset allocation adottata, i divari nei livelli di costo. Per i fondi pensione negoziali, su un orizzonte temporale di dieci anni, l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) è pari allo 0,5%; per i fondi pensione aperti, esso è dell’1,35% e per i PIP del 2,17%.
CRISI DEMOGRAFICA E PROPOSTE
La presidente Balzani nella sua Relazione si è soffermata sui condizionamenti posti dalla crisi demografica al complesso del sistema previdenziale. “In questo contesto – ha detto la presidente – possono comunque trovare spazio interventi che migliorino la capacità contributiva delle persone, specie per coloro che, per debolezze connesse alla situazione lavorativa e reddituale, anche più pesanti per le donne e per i giovani, si collocano purtroppo ai margini del sistema. Per queste persone, che pure più avrebbero bisogno di tutela nell’età anziana, un aumento delle possibilità di inclusione nel sistema previdenziale potrebbe venire, oltre che da una più sostenuta crescita delle possibilità di occupazione e da una migliore qualità del lavoro, da una rimodulazione dell’intervento pubblico. In particolare, almeno in una prima fase della partecipazione a un fondo pensione, in presenza di situazioni di debolezza, i benefici fiscali, oggi sostanzialmente espressi in termini di deducibilità dei contributi, fino a 5.164,57 euro annuali, potrebbero trasformarsi in una contribuzione di ingresso. Una simile misura, i cui effettivi contorni sono certamente rimessi alle scelte politiche, ove potesse favorire in particolare il coinvolgimento dei giovani, consentirebbe di conseguire altresì una maggiore equità intergenerazionale”.
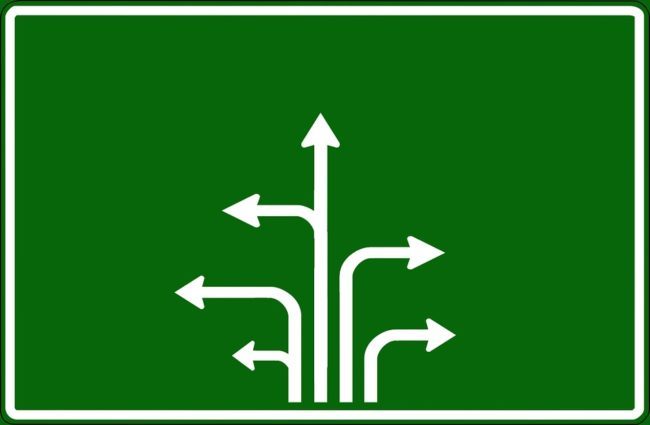
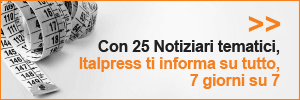

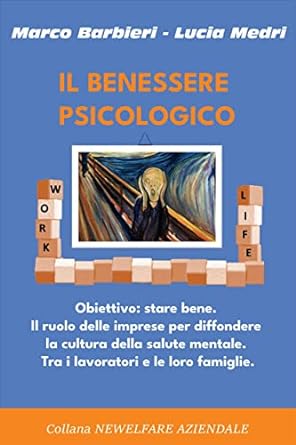
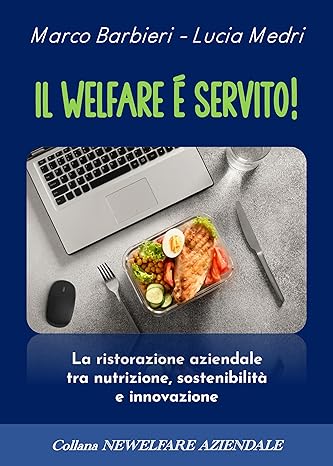












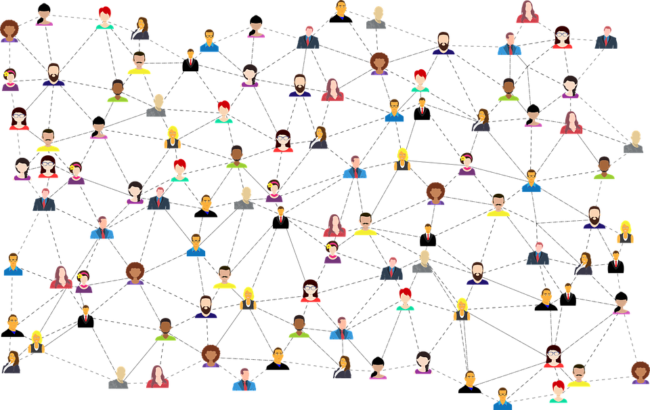


Il “quiet quitting non è una fuga ma una forma di autodifesa
Luglio 17, 2025